

Classici e capiscuola del Rock Progressivo Internazionale
G - H
 Genesis
Genesis  Gentle Giant
Gentle Giant  Gong
Gong  Grobschnitt
Grobschnitt  Guru Guru
Guru Guru  Bo Hansson
Bo Hansson  Hawkwind
Hawkwind  Heldon
Heldon  Henry Cow
Henry Cow  Steve Hillage
Steve Hillage  Hoelderlin
Hoelderlin
|
|
|
|
|
|
|
|
Nascono nel 1967 nell'ambiente universitario di Godalming (Surrey), e in una formazione a cinque, della quale già fanno parte Peter Gabriel, Mike Rutherford e Tony Banks, con John Silver e Antony Phillips, incidono nel 1968 due singoli, e quindi un album come "From Genesis to Revelation"(1969), che non suscita nessuna reazione positiva. Dopo una pausa ci riprovano nel 1970, con John Mayhew al posto di Silver come batterista: "Trespass" è un disco molto più interessante, con titoli come "The knife", articolato e intrigante brano che mostra le notevoli doti istrioniche di Peter Gabriel, cantante che diverrà in breve una vera 'icona' del nuovo rock progressivo, e in generale un primo sviluppo sinfonico di temi e suggestioni romantiche, nutrite spesso, nelle liriche, di richiami colti alla mitologia classica. Mayhew lascia la band dopo il disco, sostituito da Phil Collins, mentre alla chitarra Steve Hackett rileva Phillips: il quintetto che si viene a formare è quello destinato ai maggiori successi.  In "Nursery Cryme"(1971, qui a fianco) il processo di maturazione sembra già compiuto. E' un album sorprendentemente equilibrato nelle sue parti: si passa dalla solenne epica di "The fountain of Salmacis", spezzata da break pulsanti e accattivanti di chitarra e percussioni, alla romantica "Seven stones", con la voce di Gabriel che attraversa con grande eclettismo toni aspri e più delicati, mentre la band suona compatta una musica che sa essere vigorosa quanto enfatica. Ma tutto ruota attorno alla personalità del cantante e delle storie che riesce a colorire in una performance davvero vicina al teatro: valga per tutti la suite "Musical box", truce e fantastica piece di sangue e magia infantile, certamente da annoverare tra i caposaldi del 'progressive' di sempre. Non è certo da meno "The return of giant hogweed", con un magnifico intermezzo di piano, tastiere e chitarra elettrica a fare da ponte al canto multiforme di Gabriel. Il breve ma vivacissimo episodio di "Harold the barrel", col piano martellante assieme alla batteria di Collins per star dietro al canto, mostra quanto sia vasto il bagaglio tecnico-espressivo dei Genesis. Ormai lanciatissimi, i cinque sfondano anche in America col successivo album "Foxtrot"(1972). Siamo ancora sui livelli eccellenti del precedente, con i ventitré minuti di "Supper's ready", che replica l'exploit di "Musical box" in intensità e sagacia strumentale, e con un brano tra i più alti nella storia del gruppo: "Watcher of the skies", col suo attacco inconfondibile di tastiere che spalanca altri mondi, e la superiore malinconia delle liriche, incalzate da un grandissimo lavoro ai fianchi della chitarra di Hackett e di basso e batteria appaiati. Una prova magistrale. Alla galleria dei pezzi forti si unisce anche "Can-utility and the coastliners", con il mellotron in grande evidenza, e soprattutto "Get 'em out by friday", nervosa e altalenante sarabanda ritmica intorno a una voce che s'impenna e ricade all'infinito, con un flauto dolcissimo di sfondo. A far da contrappunto la consumata eleganza di "Time table", uno di quegli episodi che stilizzano in una dimensione quasi 'da camera' l'enfasi di altri brani, con un gioco efficace tra pianoforte e voce, e ancora la parentesi squisita di chitarra classica offerta dalla delicata "Horizons".  All'indomani del primo "Live", firmato dal gruppo l'anno seguente, esce "Selling England by the Pound"(1973, qui a destra). In questo caso l'ispirazione di Gabriel prende le mosse dalla nativa Inghilterra, un paese che già il titolo condanna pesantemente, ma che le liriche, in una vera apoteosi di satira, epica tragicomica e malinconie crepuscolari a doppio fondo, bersagliano in lungo e in largo. Sul fronte delle musiche siamo sui livelli di eccellenza ormai consolidati nelle tappe precedenti. La band suona a memoria, si direbbe, denotando una fluidità strumentale invidiabile che giustifica in pieno l'entusiasmo crescente dei fans. Dopo l'enfatica e smagliante apertura di "Dancing with the moonlit knight", il disco include un altro hit come "I know what I like", col suo arioso refrain cantabile, ma anche la suggestione romantica e potente di un pezzo come "Firfth of fifth", cucita dal pianoforte nelle sue varie fasi fino alla superba coda strumentale in cui si distingue la chitarra elettrica di Hackett. In breve, è un altro capitolo fondamentale nella discografia dei Genesis.  La summa dell'ispirazione del cantante è però contenuta nell'ambizioso doppio album dell'anno seguente: "The Lamb Lies Down on Broadway"(1974, a sinistra) è una di quelle opere che facilmente suscitano accuse di egotismo e irritazione nei critici. Gabriel immagina una sorta di surreale avventura di un suo alter-ego (Rael) nel cuore di New York, con tutti i risvolti possibili, tra satira di costume, tentazioni sociologiche e gusto puramente 'fantasy': e il risultato rimane comunque di prim'ordine, anche sul piano delle musiche. Si direbbe, anzi, che in questa nuova prova discografica i Genesis abbiano allargato ulteriormente il loro bagaglio espressivo, in una direzione più sperimentale. Accanto a pezzi che rimandano alle prove precedenti, come la stessa title-track di apertura, o la delicata "Carpet crawlers", un vero tappeto di note in crescendo, la band dà pienamente corpo alle fantasie del proprio frontman in brani 'rumoristici' e meno immediati, come "The waiting room", tra percussioni assortite e suoni distorti. Il maggiore spazio a disposizione facilita una dilatazione strumentale e soluzioni meno sintetiche, così che Tony Banks, ad esempio si permette diverse libertà coi synt e l'intera band sperimenta la fascinosa alternanza di pieni enfatici e ritmicamente sostenuti ("Back in N.Y.C.", con una voce poliedrica in primo piano) e pause strumentali di grande atmosfera evocativa, come ad esempio "Silent sorrow in empty boats". Disco giocato sapientemente sui chiaroscuri dettati dalle liriche, tra tradizione e azzardo, "The lamb lies down on Broadway" è il capitolo più composito e cerebrale dei Genesis: ma forse, nella sua estrema varietà, quello destinato a durare nel tempo.  Non è probabilmente casuale che Gabriel abbandoni i compagni proprio dopo un album così compiutamente 'suo', per iniziare una carriera solistica altrettanto fortunata, segno di grande personalità. La svolta sembra fatale al gruppo, ma il primo disco senza il cantante, "A Trick of the Tail"(1976), risulta invece un prodotto di ottima levatura. Stupisce soprattutto la padronanza di Phil Collins nel ruolo di voce solista, e non solo per la strana somiglianza col timbro di Gabriel, perlomeno nei toni più acuti. E' ancora un disco nel più classico stile-Genesis, impreziosito da brani eccellenti quali "Dance on a volcano", potente attacco nel segno di Banks, la romantiche ballate di "Entangled" e "Mad man moon" e il vivacissimo strumentale che suggella il disco, "Los Endos". Dal vivo intanto il gruppo recluta un secondo batterista come Bill Bruford, per lasciare più spazio a Collins. Anche "Wind & Wuthering"(ancora del 1976) è una prova di buon livello, nella sua vena crepuscolare e malinconica, come pure il sontuoso doppio live "Seconds Out"(1977), in gran parte registrato durante l'ennesima tournée americana. Dopo di che anche Steve Hackett lascia il gruppo per proseguire da solo. Da questo momento la stella dei Genesis inizia la sua parabola discendente. A partire dall'eloquente ( nel titolo) "...And Then There Were Three"(1978), così come pure nei seguenti, tra cui "Duke"(1980), per arrivare al più recente "Calling All Stations"(1997), realizzato dai soli Rutheford e Banks con un nuovo cantante dopo l'abbandono di Collins, peraltro tutti fortunati dal punto di vista delle vendite, niente di davvero significativo si aggiunge alla storia già esemplare della band, fissata per sempre dalla fantastica successione degli album usciti tra il 1971 e il 1976. Quello dei Genesis resta un nome assolutamente basilare nello sviluppo del sound progressivo più classico.
Dischi consigliati: Tra i più sofisticati interpreti di certo rock barocco che fece scuola nei primi anni Settanta, i Gentle Giant hanno avuto una carriera non lunghissima ma piuttosto coerente, con un livello qualitativo davvero eccelso. Imperniato sui tre fratelli di origine scozzese Ray, Phil e Derek Schulman, che fondano il gruppo sulle ceneri dei Simon Dupree and the Big Sound (unico album realizzato nel 1969: "Without Reservations"), il Gigante Gentile si è rivelato nel primo disco omonimo (a sinistra ecco la copertina), pubblicato nel 1970, dimostrando subito una qualità tecnica superiore alla media nell'assemblare una straordinaria serie di richiami e influenze: musica da camera, echi sinfonici e barocchi, folk e rock puro convivono in un contesto di grande eleganza che non esclude affatto la ricerca di sonorità più sperimentali e audaci. Un ruolo importante, a parte le ricche tastiere di Kenny Minnear (impegnato anche al violoncello), è ricoperto dai fiati, specie tromba e sax (Phil Schulman) e anche dall'ottima impostazione delle voci, a tratti corali, che creano suggestive armonie. L'esempio migliore è il brano più lungo del disco, "Nothing at All", ma non da meno è "Alucard", nel consueto intreccio di spunti roccheggianti nei quali spicca l'incisiva chitarra solista di Gary Green. Rifinito e complesso in ogni sua sfumatura, il disco propone anche temi più colti e virtuosistici, proposti con ammirevole affiatamento da una band in stato di grazia. E' soprattutto nel successivo "Acquiring the Taste" (1971, a destra), forse il più impeccabile della loro discografia, che la formazione britannica stupisce per la disinvolta assimilazione di tanti elementi diversi all'interno di composizioni ricercate e godibili al tempo stesso. Brani come "Pantagruel's Nativity", che apre sontuosamente l'album, "The Moon is Down", dalla magica e umbratile atmosfera, o la più robusta "Wreck", arricchita da splendide aperture di flauto e chitarra, restano tra le cose più ragguardevoli del decennio. I Gentle Giant si divertono tra l'altro a giocare col proprio nome e affollano i loro testi di allusioni più o meno esplicite ai vari Gargantua, Panurge e Pantagruele, cioè i giganti protagonisti dell'opera letteraria di Francois Rabelais.Questo perfetto equilibrio si conserva anche nei lavori successivi, dove prima Malcom Mortimer e quindi Pugwash Weathers rimpiazzano alla batteria Martin Smith, in una sequenza di autentici gioielli. Si parte con il raffinato concept-album "Three Friends"(1972), un imperdibile affresco sonoro dedicato alla storia di un'amicizia nel corso del tempo, e dilatato in sei momenti di classe cristallina e tecnica impressionante.Sempre nel '72 è pubblicato quindi il superbo "Octopus" (sotto a sinistra), da qualcuno indicato come il momento migliore del gruppo. Composto di otto tracce, è in ogni caso un'altra prova magistrale della formazione, impreziosita da alcune perle assolute: l'iniziale "The Advent of Panurge" è un sincopato arazzo con pregevoli armonie vocali, ma ci sono un paio di vigorosi rock come "A Cry For Everyone" e poi il frastagliato manifesto strumentale di "The Boys in the Band", tra pause e ripartenze continue, fino alla dolcissima atmosfera che pervade "Think of Me With Kindness". Soprattutto è da rimarcare, una volta di più, come la complessità strumentale dei singoli pezzi fluisca con apparente semplicità, in un impasto brillante e cesellato con cura certosina, eppure mai pesante per l'ascoltatore. Un album praticamente perfetto.
Il successivo "Interview" (1976), mostra invece un'ispirazione che ristagna, forse perché, per ammissione dello stesso Derek Shulman, è registrato nel solco del precedente. Il gruppo indulge insomma nei propri stilemi, ma ovviamente parliamo di eccellenti stilemi, che non abbassano mai la qualità media: sono belle soprattutto l'incalzante "Another Show", con l'organo di Minnear e la voce in grande spolvero, e anche la più complessa "Timing", tra violino e chitarra che catturano l'attenzione, mentre il resto, seppur suonato con il gusto di sempre, nulla aggiunge di nuovo. La verità è che anche i Gentle Giant, come tutto il movimento Progressive della prima ora, risentono del repentino cambiamento nei gusti del pubblico, attratto da nuovi fenomeni come il Punk e la Disco Music, che guadagnano in fretta considerevoli quote di mercato.
Curiosamente, proprio nello stesso periodo, cresce enormemente il loro seguito negli Stati Uniti, dove la band finisce per stabilirsi nel 1979, giusto nello scorcio finale della propria attività: è proprio in terra americana, infatti, che viene registrato nel 1980 "Civilian", cioè l'ultimo disco ufficiale del Gigante Gentile. Nonostante un leggero calando qualitativo, in ogni caso, chi davvero voglia afferrare la complessità e il generoso spirito di contaminazione che ha nutrito il rock progressivo nel suo momento d'oro, non può assolutamente prescindere da questo gruppo di geniali strumentisti: i loro dischi, specie quelli del periodo 1970-'75, restano di fatto imperdibili. Dischi consigliati:  Guarda il video di "The Advent of Panurge" (German Tv live, 1974) Guarda il video di "The Advent of Panurge" (German Tv live, 1974)L'utopia dell'universo freak applicata allo space rock tipicamente anni Settanta: questa in sintesi potrebbe essere la migliore definizione per i Gong. Il gruppo è una creatura di Daevid Allen, australiano di Melbourne dallo spirito nomade, che nel 1967 non può seguire i Soft Machine in Inghilterra per problemi di passaporto, e perciò rimane in Francia. Qui, oltre a vivere intensamente i fermenti del '68, stringe diverse collaborazioni con musicisti locali, conosce l'anima gemella Gilli Smyth e il fiatista Didier Malherbe, e infine fonda i Bananamoon Band, poi rinominati Gong: è il 1969.Il primo atto firmato dalla nuova band è un album come "Magick Brother", registrato nel 1969 e pubblicato l'anno seguente dalla francese BYG Records. Seppure non sempre calibrato a dovere, è una sequenza dove l'estro debordante di Allen si traduce in dieci episodi intrisi di umorismo e sfrenata libertà espressiva, preparando così il terreno alle successive e più mature prove. Spunti di psichedelia pura ("Mystic Sister: Magick Brother" o "Princess Dreaming") e atmosfere intriganti a carattere quasi onirico per voce e chitarra ("Rational Anthem"), tra melodie pop traballanti sul pianoforte ("Ego") oppure più spesso cullate dal sax di Didier Malherbe ("Gong Song" e anche "5 & 20 Schoolgirls"), convivono con strane filastrocche rock, ad esempio "Chainstore Chant: Pretty Miss Titty", per le voci mai banali di Allen e Gillie Smith. Un impasto davvero imprevedibile, che rimane tra i picchi della band almeno sul piano dell'invenzione pura, senza filtri.  In pieno fermento creativo, e alle prese con progetti diversi come ad esempio "Continental Circus" (1972), colonna sonora per un film/documentario dedicato all'ambiente del motociclismo, Allen e compagni proseguono la loro ascesa nel circuito alternativo con "Camembert Electrique" (a destra), ancora su BYG Records. Schierati a cinque, i Gong sviluppano un singolare impasto di rock spaziale, sempre dominato dai fiati di Malherbe, la chitarra di Allen e la voce femminile della sua compagna Gilli Smyth. Undici tracce colorate, suonate con un gusto molto anarchico per i paradossi, le fantasie vocali e le improvvisazioni sopra le righe, già molto personali, come l'iconografia hippie che circonda la band. L'accoppiata di sax e chitarre acide incide in "You can't kill me" e in altre filastrocche stranianti ("Mister long shanks: O mother I am your fantasy" e "Tried so hard"), accanto a richiami cosmici e suggestive atmosfere drammatiche. "Fohat digs boles in space" è tra i momenti più aperti, tra liquide tastiere, vocalizzi e pulsazioni ritmiche, mentre la lunga "Tropical fish: Selene" compendia le anime del disco allineando umori irriverenti e audaci accostamenti musicali. Nei titoli compaiono alcuni accenni all'ossatura della vera saga spaziale che prenderà corpo solo dal disco seguente. In pieno fermento creativo, e alle prese con progetti diversi come ad esempio "Continental Circus" (1972), colonna sonora per un film/documentario dedicato all'ambiente del motociclismo, Allen e compagni proseguono la loro ascesa nel circuito alternativo con "Camembert Electrique" (a destra), ancora su BYG Records. Schierati a cinque, i Gong sviluppano un singolare impasto di rock spaziale, sempre dominato dai fiati di Malherbe, la chitarra di Allen e la voce femminile della sua compagna Gilli Smyth. Undici tracce colorate, suonate con un gusto molto anarchico per i paradossi, le fantasie vocali e le improvvisazioni sopra le righe, già molto personali, come l'iconografia hippie che circonda la band. L'accoppiata di sax e chitarre acide incide in "You can't kill me" e in altre filastrocche stranianti ("Mister long shanks: O mother I am your fantasy" e "Tried so hard"), accanto a richiami cosmici e suggestive atmosfere drammatiche. "Fohat digs boles in space" è tra i momenti più aperti, tra liquide tastiere, vocalizzi e pulsazioni ritmiche, mentre la lunga "Tropical fish: Selene" compendia le anime del disco allineando umori irriverenti e audaci accostamenti musicali. Nei titoli compaiono alcuni accenni all'ossatura della vera saga spaziale che prenderà corpo solo dal disco seguente. Nel 1972 la band si lega alla Virgin e si trasferisce così in Inghilterra, dove esce "Flying Teapot" (1973, a fianco). Primo atto della trilogia del pianeta Gong, l'album è un passo avanti decisivo nell'immaginario anarchico-libertario di Allen, più serio di quel che traspare dai toni fantasy della storia: Zero e altri compagni sbarcati su Gong dalla teiera volante del titolo, che ospita una radio pirata dall'eloquente nome di Radio Gnome, incontrano strani personaggi e situazioni che trascendono ovviamente ogni logica. Chiaro che i suoni risentano di un tale spunto, anche grazie all'ingresso stabile di tastiere e synth (Tim Blake) e di un chitarrista nuovo di zecca come Steve Hillage, altro personaggio basilare del giro di Canterbury e fresco reduce dall'esperienza coi Khan, mentre subentrano al basso l'ex-Magma Francis Moze, con Christian Trisch che torna alla chitarra, e Laurie Allan alla batteria. Gli ingredienti sono gli stessi del disco precedente, ma messi a fuoco in maniera più organica. Bella soprattutto la traccia che intitola l'album, con l'efficace bilanciamento tra la progressione di basso e batteria, il sax di Malherbe e le avvolgenti spirali sintetiche. L'altro pezzo forte, oltre al cantabile girotondo di "The Pot Head Pixies", è "Zero the Hero and the Witch's Spell", che attraverso un fitto tappeto percussivo scivola in lunghe variazioni jazzistiche ancora dominate da sax, il basso creativo di Moze, oltre al synth e i vocalizzi di sfondo della Smyth, che diventa insinuante protagonista nella conclusiva "Witch's Song, I am your Pussy". Sicuramente prezioso, anche se poco convenzionale, è l'apporto di Hillage alle sonorità del gruppo. Nel successivo "Angel's Egg" (ancora 1973, qui a fianco) il chitarrista sarà decisamente tra i protagonisti assoluti. E' un album meglio prodotto, che porta a piena maturazione i temi già espressi, con qualche idea più melodica e accattivante che arricchisce la sequenza. La chitarra solista di Hillage, che non a caso firma tre brani, caratterizza episodi come "Castle in the Clouds" e soprattutto "Love is How you Make it", in combutta con il sax di Malherbe, fino a "I Never Glid Before", una traccia trascinante, tra breaks continui e le spirali incisive del sax. Tra gli altri episodi sono di grande impatto anche "Sold to the Higest Buddha" e più ancora "Oily Way", dal facile giro armonico, ma non mancano i consueti sapori esotici molto speziati: in particolare "Other Side of the Sky", immersa in spirali cosmiche di grande effetto con ficcanti accelerazioni, quindi "Flute Salad" e "Outher Temple", altro esempio di space-rock contrassegnato dall'accoppiata vincente di sax e synth. Gilli Smyth, dal canto suo, caratterizza vocalmente un altro pezzo di sensualità a doppio fondo come "Prostitute Poem". Insomma è un disco che rappresenta il sofisticato punto di equilibrio tra l'estrosa creatività di Allen e un'impeccabile cura dei suoni, e dunque cristallizza definitivamente il valore e il seguito della band, anche se da qui comincia una parabola più alterna, tra luci e ombre. "You" (a sinistra), pubblicato nel 1974, è un altro disco di livello, ancora ben prodotto, ma per la prima volta affianca l'umorismo trasgressivo degli inizi con motivi più seri e pensosi. E' il caso dell'apertura per flauto e voce ieratica di "Thoughts For Naught" e anche della sequenza "Magic mother invocation"/"Master builder", vero mantra che cresce sulle percussioni del nuovo Pierre Moerlen e impasta poi sax, synth e chitarra elettrica in uno schema di buon effetto. Suggestiva la lunga cavalcata elettronica di "A Springkling of Clouds", degna dei corrieri cosmici tedeschi, con un finale più mosso nel quale spicca il flauto di Malherbe. I restanti pezzi recuperano i toni di sempre, a partire dal breve "Perfect Mistery", e soprattutto con la chiusura di "You Never Blow yor Trip Forever", che sfoggia il consueto repertorio di voci alterate e beffarde, ritmi irregolari, cromatismi elettronici e spunti improvvisati. "The Isle of Everywhere", invece, è un cadenzato jazz-rock dai contorni liquidi e un po' di maniera, con lunghe tirate della chitarra di Hillage. Allen abbandona con Gilli Smyth l'anno seguente, e Hillage se ne va dopo "Shamal" (1975). Quest'ultimo disco, seppure privo dell'impronta psichedelica e genialoide di Allen, è un album discreto, dominato da un morbido jazz-rock dai confini elastici, con i fiati di Malherbe in primo piano ("Wingful of Eyes" o l'eterea "Mandrake"), intriganti influenze orientali ("Bombooji") e buone parti di violino dell'ospite Jorge Pinchevsky ("Cat in Clark's Shoes") integrate nel sound del gruppo. In seguito però i Gong, guidati a questo punto da Pierre Moerlen, infilano dischi ben suonati ma più convenzionali che portano la band, brillante capostipite di tanto space-rock alternativo, a perdere le sue qualità migliori. Con fasi alterne ma immutata verve, Hillage e Allen proseguono comunque le rispettive carriere solistiche. A sorpresa, però, in pieni anni Novanta l'australiano resuscita la sigla Gong per incidere nuovi capitoli della saga incompiuta, a cominciare da "Shapeshifter" , un album del 1992 che riaccende l'interesse intorno a un gruppo storico che, indiscutibilmente, non merita affatto l'oblio. Dischi consigliati:  Guarda il video di "Oily way/Outer Temple/Inner Temple" (Live) Guarda il video di "Oily way/Outer Temple/Inner Temple" (Live) GROBSCHNITT Formati ad Hagen nel 1970 come evoluzione di una formazione degli anni Sessanta, The Crew, i Grobschnitt sono uno dei gruppi più noti e singolari della scena prog tedesca. La loro peculiarità è nel carattere eminentemente teatrale e cabarettistico che soprattutto nelle esibizioni live li rendeva davvero unici: questo lato della loro musica, che fatalmente si perde nei dischi a parte un bizzarro umorismo qua e là, si riflette anche nei nomi dei componenti, tutti di fantasia: Lupo, Eroc, Wildschwein (cioè "maiale selvatico"), Baer ("orso"), e così via.  Dopo i primi concerti nel 1971, il gruppo viene messo sotto contratto dalla Brain e realizza il suo primo album omonimo nel 1972, con un curioso organico a sei, nel quale spicca la presenza di ben due batteristi come Joachim Ehrig (Eroc) e Axel Harlos (Felix), accanto alle tastiere di Hermann Quetting (Quecksilber), la chitarra solista di Gerd-Otto Kuhn (Lupo) e quella ritmica del cantante Stefan Danielak (Wildschwein), oltre al bassista e flautista Bernhard Uhlemann (Bear). Si tratta di quattro composizioni che offrono tutto il versatile repertorio dei Grobschnitt, capace di spaziare tra rock sinfonico e le sonorità spaziali tipiche del kraut-rock. Esemplare in tal senso è soprattutto la lunga "Symphony", dove l'organo gotico e una chitarra solista carica di effetti incidono in un quadro elegante e ben articolato. L'altro pezzo forte, che per alcuni versi sembra anticipare la celebre suite "Solar music", è la finale "Sun trip", che scorre tra spirali di vento e voci ieratiche, prima di aprirsi su scenari imprevedibili, effetti speciali inclusi, tra spunti jazzati, curiose marcette, e il pathos dell'organo a legare i diversi momenti insieme alla chitarra. Eccellente anche la voce di Danielak, che diverrà il marchio di fabbrica del gruppo, di volta in volta sopra le righe oppure calda e persuasiva. "Travelling" è invece un robusto rock, ma con ritmica di forte impronta latinoamericana e chitarra alla Santana, mentre nel breve "Wonderful music" il flauto e le chitarre acustiche mostrano un lato ancora diverso del gruppo tedesco. L'esordio mette subito i Grobschnitt in evidenza nel panorama rock teutonico, ma il gruppo deve ancora esprimere le sue vere potenzialità. In realtà, quando nell'estate del '72 Quetting e Harlos lasciano i compagni, la band attraversa mesi di incertezza, finché si sceglie di continuare, ma su basi del tutto nuove: da questo momento Grobschnitt diventa sinonimo di un vero e proprio "happening" itinerante, quasi una compagnia circense che sintetizza musica, teatro e satira in spettacoli che cominciano a fare sensazione. E infatti "Ballermann", il doppio LP pubblicato nel 1974 con l'ingresso del nuovo tastierista Volker Kahrs (Mist), mostra subito una verve diversa. Se l'attacco di "Sahara", cantato da Eroc con un buffo sproloquio introduttivo ("Do you like it? Yes, you do!"), è un rock sincopato attraversato da umori decisamente "alcolici", il resto della raccolta ci mostra una band tecnicamente più esuberante e ricca di sorprese. "Nickel-odeon" evidenzia la qualità d'interprete di Danielak, all'interno d'un brano atmosferico che varia poi sulle corde della chitarra solista e le tonalità dell'organo, con potenti breacks ritmici nel mezzo. "Morning song" è un sapiente manifesto dell'arte minimalista dei cinque, costruito su semplici giri armonici che cullano il canto solista, fino a impennarsi nel finale sulla chitarra elettrica. Bella anche l'atmosfera trasognata di "Drummer's dream", ravvivata da gustosi cambi di tempo, ma il pezzo forte dell'album è indubbiamente la lunga suite in due parti "Solar-Music". Portando a maturazione le sonorità cosmiche tipiche del krautrock, ma immerse stavolta in un tessuto rock aperto e variegato che funge da cornice, la band esprime finalmente tutto il suo potenziale in una musica estremamente evocativa. Arpeggi di chitarra galleggiano sospesi in una dimensione diversa, finché l'organo, le percussioni e infine la chitarra solista ritrovano il loro spazio in un crescendo frastagliato, tra pieni e vuoti di grande suggestione. Psichedelia e space-rock al grado più sperimentale, concorrono in ugual misura al sontuoso risultato finale, nel quale è facile cogliere richiami alla lezione dei Pink Floyd, ma trasfigurata in un contesto strumentale eclettico e ricco di sfumature che approda poi, paradossalmente, a un delicato tema da camera. Spicca, accanto alla smagliante chitarra solista di Kuhn e agli effetti elettronici di Kahrs, il grande lavoro percussivo di Eroc, ma è uno di quegli episodi che mostrano soprattutto l'amalgama perfetto tra le parti e l'affiatamento raggiunto tra i singoli.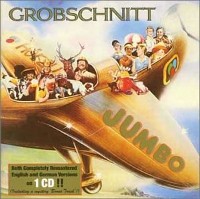 L'album che segue segna una piccola svolta stilistica. In "Jumbo", realizzato nel 1975 col nuovo bassista Wolfgang Jèger (Popo) al posto di Uhlemann, il gruppo sterza verso un rock più fluido e compatto, con toni decisamente meno umorali del solito, anche se non del tutto privi di ironia. Proprio per questo, comunque, è un album molto bello, che soprattutto lascia emergere una godibile vena melodica, esaltando le parti vocali e le brillanti combinazioni tra chitarra e tastiere. Tutte caratteristiche evidenti nell'atmosfera della lunga "Sunny sunday's sunset", piuttosto vicina ai Genesis, basata s'un efficace crescendo sonoro. Della stessa pasta l'apertura di "The excursion of Father Smith", con un testo molto critico verso la superficialità di certi ambienti sociali. Al tema si ricollega anche "The clown", segnata dai brillanti riff chitarristici, mentre "Dream and reality" parte in sordina e nella seconda parte cresce d'intensità grazie alla pungente chitarra e al synth di Kahrs. Un disco molto curato, non a caso registrato nello studio dal famoso produttore Conny Plank, che piace molto al pubblico e che viene realizzato l'anno seguente anche in lingua tedesca. A questo punto, la crescente popolarità raggiunta in patria spinge la band a impegnarsi in un progetto ancora più vasto. "Rockpommel's land", pubblicato nel 1977, è infatti una sorta di ambiziosa rock-opera d'argomento fantastico, basata sulle avventure del piccolo Ernie, che fugge da casa e attraversa avventure e pericoli sulle ali della sua curiosità, accompagnato dal favoloso uccello Maraboo, e confrontandosi spesso con realtà che rappresentano il Bene e il Male. Il tema scelto influisce sulla musica che si ammorbidisce ulteriormente, privilegiando atmosfere soffuse, complessi arrangiamenti e parti di taglio sinfonico. Anche se non mancano dissensi nel gruppo stesso, con Eroc che definisce il disco "musica intellettuale, estremamente complicata", e insomma meno "rock" del solito, non c'è dubbio che si tratti di un grande disco, e per molti anzi il vertice espressivo dei Grobschnitt. Abbastanza inediti ma perfettamente inseriti nel contesto sono certi episodi acustici, come la breve "Anywhere", dove risalta la voce di Danielak, mentre gli altri tre momenti privilegiano strutture sinfonico-classicheggianti, orchestrate con grande cura per ogni dettaglio. "Ernie's reise", che apre il disco, introduce il carattere positivo del protagonista, passando gradualmente da morbidi passaggi acustici a più incisive parti strumentali. In grande spolvero le tastiere di Kahrs che sorreggono lo sviluppo progressivo del tema. In "Severity town", che rappresenta l'incontro con il Male, il tessuto strumentale prende corpo sul piano classicheggiante e cresce d'intensità con una voce sopra le righe e poi sulla chitarra solista di Lupo: l'andamento più mosso e l'uso di effetti elettronici suggeriscono l'aspetto ostile della metropoli. La lunga traccia finale che intitola il disco sviluppa in circa venti minuti, ancora più organicamente, la complessa natura dell'opera: è una sorta di ramificato crescendo sottolineato dalla batteria marziale di Eroc, dalle tastiere avvolgenti e sontuose, i limpidi inserti di chitarra e il pathos delle parti vocali, tutto unificato da una complessa orchestrazione che sancisce il lieto fine del viaggio.L'album supera le centomila copie in Germania, e dunque è un vero successo popolare oltre che di critica. Sull'onda del momento propizio, nel 1978 la band realizza un disco come "Solar Music Live", dove la suite contenuta in "Ballermann" viene riproposta dal vivo in una versione doppia e davvero irresistibile: è forse uno dei migliori dischi "live" dell'epoca, superbo nella sua fusione di qualità sonora e straordinaria capacità esecutiva. Un'ora di musica potente e ipnotica, senza un attimo di pausa, che lascia il segno e diventa un altro successo commerciale.Seguono dischi come "Merry-go-round" e "Illegal", ancora premiati dal pubblico, ma subito dopo la formazione comincia a mutare pelle. Se ne vanno prima il bassista Jager, poi Kahrs e poi lo stesso Eroc nel 1983, e i ricambi di organico indirizzano lo stile della band verso un rock diverso, in sintonia con il neo-prog degli anni Ottanta. Nel dicembre 1989, infine, i Grobschnitt chiudono la loro intensa parabola con un concerto d'addio nella loro città d'origine, Hagen. A conti fatti, restano uno dei nomi basilari della scena progressiva germanica, e non solo per la ricca discografia che abbraccia due decenni, ma per il carattere estroso e creativo col quale hanno sempre vissuto la loro esperienza di musicisti rock. Dischi consigliati: · Sito ufficiale Il nome del tastierista svedese Bo Hansson, non sempre ricordato nella storia del progressive, merita invece un suo spazio di rilievo tra coloro che hanno segnato l'affermarsi e l'evoluzione di questo genere. Non c'è dubbio, infatti, che la sua opera abbia anticipato diverse esperienze successive: quella di Mike Oldfield, ad esempio, ma anche i raffinati racconti strumentali dei Camel.Nato a Göteborg nel 1943, come molti della sua generazione comincia adolescente una trafila tra i molti gruppi che suonano rock and roll a Stoccolma, ma ancora in veste di chitarrista. Forma anche un suo complessino che suona blues, The Merrymen, ma tutto cambia nel 1966, quando Hansson vede esibirsi in concerto l'organista jazz americano Jack McDuff: decide di mollare il suo gruppo e acquista il suo primo organo. Di lì a poco entra in contatto con il batterista Janne Carlsson, e i due decidono di sviluppare insieme una nuova proposta musicale sotto la sigla Hansson & Karlsson. Il sodalizio frutta tre dischi, a partire da "Monument" (1967), e il duo guadagna una grande fama in patria. Tra l'altro Jimi Hendrix, colpito dalla loro musica, li vuole con sé sul palco in un paio di serate in terra svedese, e più tardi registrerà anche un pezzo firmato da Hansson: "Tax Free". La musica del duo, che miscela in maniera ingenua atmosfere psichedeliche e ambizioni classiche, per quanto oggi datata, suona comunque piuttosto innovativa per l'epoca, e Hansson ha modo di affinare lentamente la sua tecnica in queste lunghe sgroppate all'organo, assecondato dalla batteria del compagno.  Quando poi Carlsson diventa un attore di successo, alla tivù svedese e poi al cinema, Hansson sceglie di proseguire per suo conto l'attività di musicista. Lo spunto vincente per la sua parabola solista è la lettura del celebre romanzo fantasy "Il signore degli anelli" di Tolkien, che mette in moto alcune suggestioni destinate a tradursi nel suo album d'esordio, intitolato appunto "Sagan Om Ringen", e pubblicato nel 1970 dalla Silence Records. Interamente strumentale come i tre che seguono, è un disco diviso in dodici quadri, in genere piuttosto brevi, capace di creare atmosfere rarefatte e al tempo stesso esotiche, in bilico tra folk, pop sinfonico e psichedelia. Come si nota fin dall'apertura ad effetto di "Första vandringen", Hansson predilige trame sognanti e spesso minimaliste, basate soprattutto sull'organo e il synth, lasciando però il giusto spazio ai musicisti chiamati a collaborare, specie alle chitarre. Tra i momenti più felici c'è sicuramente "Den gamla skogen - Tom Bombadill", con le sue progressioni di organo bilanciate da suoni ad effetto della chitarra, e poi "Lothlórien", più misteriosa nel suo incedere. Compassata e intrisa di fascinosi richiami gotico-psichedelici scorre anche "I Elronds hus - Ringen vandrar söderut", mentre l'atmosfera si scalda in brani come "Rohans Horn - Slaget vid Pelennors slätter", con la chitarra elettrica in evidenza, il sassofono, e percussioni molto latine, come avviene anche in "De svarta ryttarna - Flykten till vadstället", dove si ascoltano le congas di Bill Öhrström. Anche se oggi la sequenza può apparire "naive" in alcuni momenti, rimane un progetto davvero originale, per l'idea di partenza e la sua realizzazione strumentale, che ha finito per ispirare l'immaginario prog degli anni a venire. L'album suscita interesse anche fuori dalla Svezia, tanto che due anni dopo la Charisma ne pubblica una versione inglese dal titolo "Lord of the Rings", che arriva al 34° posto delle charts britanniche, facendo conoscere il nome del tastierista in gran parte d'Europa.  Forse deluso dal responso, invece che dedicarsi a tour promozionali come vorrebbero i suoi discografici, il tastierista si isola per comporre del nuovo materiale. A questo proposito, va sottolineato che il musicista svedese non ha mai eseguito dal vivo la sua musica da solista, privilegiando sempre il lavoro di composizione e registrazione in studio. Passano comunque tre anni prima che Hansson si affacci di nuovo sul mercato: lo fa con uno dei suoi album più ambiziosi, ma disuguali, cioè "Mellanväsen", registrato ancora a Stoccolma e pubblicato in patria nell'Ottobre del 1975. La Charisma lo fa uscire invece all'inizio del 1976 col titolo "Attic Thoughts". Con la solita ricca strumentazione, stavolta garantita soprattutto da diversi membri del gruppo Kebnekaise, l'album parte alla grande con la stupenda minisuite in tre tempi "Funderingar på vinden", dove le tastiere del leader, che si destreggia a dovere tra organo, synth e pianoforte, sono ben assecondate dalla chitarra e dalla batteria. E' tra i momenti più alti di Hansson, ma il disco vive di alti e bassi. L'altra suite dell'album è "Kaninmusik" ("Rabbit Music"), e segue un andamento più pittoresco e fantasioso. Ancora molto bella è "Väntan..." ("Waiting..."), dominata da un motivo solenne e malinconico che permea tutta la composizione, con l'improvvisa accelerazione ritmica nel finale. "Dag och natt" ("Day and Night") colpisce per il contrasto cromatico tra la frenesia del giorno e l'assorta atmosfera notturna, sottolineata dal moog e da pacati arpeggi chitarristici, mentre decisamente briosa è la chiusura di "Lyckat upptåg", sviluppata sui brillanti fraseggi dell'organo e della chitarra. "Vals för mellanväsen"("Waltz for Interbeings"), tra ritmi quasi funky e inserti di violino, sviluppa una sorta di folk trasversale con il synth a fare da collante. Sono brani interessanti, per via di certi accostamenti inusuali, anche se in verità non sempre riusciti. Il successo internazionale sembra aver abbandonato il tastierista, che due anni dopo pubblica comunque il suo quarto disco, intitolato "El-ahrairah", realizzato con il solito gruppo di strumentisti fidati, ma col nuovo produttore Pontus Olssen. Il nome del titolo è quello di uno dei conigli che popolano il racconto "Watership Down" di Richard Adams (tradotto in Italia come "La collina dei conigli"), opera che aveva già ispirato la suite "Kaninmusik" nel disco precedente, e infatti l'edizione inglese dell'album si chiama "Music Inspired by Watership Down". Considerata a volte una prova più debole delle precedenti, è invece un esempio di maturità raggiunta dal tastierista, soprattutto negli arrangiamenti, come è facile notare ascoltando la brillante suite che apre la sequenza, "Utvandring". Fresca e vivace, con il consistente apporto chitarristico di Kenny Håkansson, vero protagonista di tutta la sequenza, la composizione scorre dinamica e ricca di finezze, incorporando anche pause più raccolte di grande fascino nelle quali si fa notare il flauto. Non sfigurano affatto al confronto la breve "Skogen", divisa tra pieni e vuoti strumentali di notevole impatto, e soprattutto la lunga "Watership Down", immersa in un clima ancora più sinfonico, che procede elegante e alla fine solenne sul synth di Hansson affiancato a dovere dalla chitarra solista. In coda, il tastierista sigilla col suo pianoforte meditativo un altro disco di valore e al tempo stesso il suo ciclo maggiore.Seguono infatti lunghi anni di silenzio, abbastanza misteriosi, finché nel 1985 è pubblicato, ma soltanto in Svezia, un ultimo disco intitolato "Mitt i livet" (cioè "La mia vita"). E' una semplice raccolta di canzoni pop e folk in lingua svedese, con voci femminili e maschili, che per quanto gradevoli non hanno davvero nulla da spartire con i quattro dischi precedenti. Una tardiva riunione col vecchio compagno Janne Carlsson per una serie di concerti, con l'uscita di una compilation ancora firmata Hansson & Karlsson nel 1998, pone di fatto fine alla parabola del tastierista. La sua bella musica conosce peraltro una rinnovata popolarità, e non solo in Svezia, dove l'artista è considerato giustamente una leggenda, soprattutto in seguito alla ristampa del catalogo 1970-1977 curata dalla Silence Records. All'età di sessantasette anni, Bo Hansson si è spento a Stoccolma il 23 Aprile 2010. Dischi consigliati: · Bo Hansson sul sito Silence Records Questa valida formazione inglese, non sempre ricordata come meriterebbe, riassume i tratti migliori del cosiddetto RIO (Rock In Opposition), movimento di avant-prog transnazionale che ha portato avanti per anni un'idea di musica indipendente e aliena da ogni compromesso, per forza di cose dunque condannata a una certa marginalità rispetto alle formule più popolari. Restano comunque sia, di questa coraggiosa esperienza, dischi affascinanti, di grande personalità artistica e senz'altro da riscoprire.  A formare gli Henry Cow nel 1968 sono Fred Frith (chitarra, violino) e Tim Hodgkinson (tastiere, fiati), nell'ambito della rinomata università di Cambridge: data e contesto sembrano sintomatici, perché mettono insieme i fermenti politici dell'epoca con un certo grado di intellettualismo che sono indubbiamente alla base della musica realizzata dal gruppo. Dopo una prima apparizione al Festival di Glanstonbury nel 1971, la band si stabilizza come quintetto. Di lì a poco, viene quindi scritturata dalla Virgin e nel 1973 pubblica "Leg End" (a sinistra), un primo atto discografico che contiene già l'essenza di un'ispirazione destinata a diventare proverbiale. Tra free jazz, improvvisazione e voci disturbanti qua e là, il disco regala momenti suggestivi come "Amygdala", una splendida deriva a schema aperto con i fiati e la chitarra in particolare evidenza, ma senza nessuna forzatura. Ci sono poi dissonanze, suoni sperimentali e spigolosi con il sax di Geoff Leigh in primo piano, il violino di Frith, e la ritmica elastica, che tiene il passo delle svolte imprevedibili dello spartito: il basso saltellante di John Greaves e la batteria di Chris Cutler. Questo è pure il condensato di un episodio emblematico come "Teenbeat", che davvero cattura uno stile. La chitarra solista balza in cattedra in "Teenbeat Reprise", brano che non stonerebbe nel repertorio dei King Crimson più neri e affilati: ancora splendido il basso, mordente il tempo percussivo, eccentrico il pianoforte. Anarchia e rumorismo ("The Tenth Chaffinch") vanno di pari passo con coretti stranianti cullati da organo e violino in una dimensione ancora inedita ("Nine Funerals of the Citizen King"), che suona melodica e inquietante al tempo stesso. Magistrale. In confronto all'esordio, "Unrest" (a destra), uscito nel 1974 dopo un tour inglese con i Faust, suona per certi versi anche più ostico e composito. Leigh se n'è andato, mentre entra in organico la brava Lindsay Cooper, musicista che si divide abilmente tra oboe e fagotto, assicurando nuove suggestioni di ascendenza classica al sound della band. Lo si vede già nell'iniziale "Bitten Storm over Ulm", trasognato brano per il resto giocato sulla chitarra elettrica e il basso, e poi nella più lunga "Half Asleep, Half Awake": è una musica colta, cerebrale, come dice il titolo sempre in bilico tra sogno e realtà, dalle tonalità sommesse eppure cangianti, dunque inafferrabili. Qui sta forse il maggior legame, da molti sottolineato, con l'anima della coeva scuola di Canterbury. Tutto questo viene dilatato nella lunga "Ruins", altro pezzo forte del repertorio, a volte rarefatto fino al silenzio, con ampio spazio per i fiati e il violino tra improvvisi sussulti ritmici. Se le prime quattro tracce dell'album sono scritte, il resto è invece costituito da improvvisazioni poi rielaborate in sede di missaggio: cosa che, ovviamente, rende molto più alto il tasso sperimentale della musica, a cominciare da "Linguaphonie", costruito sulle voci, fino alla conclusiva "Deluge", fascinosa progressione di percussioni e labili tracce di una melodia superstite.Del 1975 è l'incontro artistico con il trio Slapp Happy, formazione di avant-pop ai confini del cabaret, capitanata dalla cantante tedesca Dagmar Krause: il risultato è il controverso "Desperate Straights", disco nel quale le ambizioni sperimentali di Frith e compagni vengono diluite in uno schema più cantabile, ma per niente canonico, mentre il reticolo dinamico dei suoni è basato soprattutto sui fiati. Non solo sax e clarinetto, ma anche la tromba e il trombone di Mongezi Feza e Nick Evans sono protagonisti del disco, anche se è la vocalità camaleontica della Krause, ironica e nutrita di echi brechtiani, a dominare la scena. Brillanti soprattutto "The Owl" e "In the Sickbay", ad esempio, inframmezzate da strumentali jazz fin troppo canonici, come la title-track. 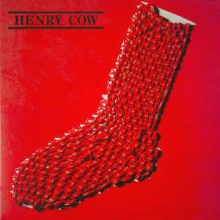 Il trio di Amburgo confluisce quindi nella band inglese per un lavoro più riuscito come "Praise of Learning", ancora del '75 (a sinistra): il folto organico è più o meno lo stesso, ma più affiatato e consapevole. Dopo la grintosa apertura di "War", in linea col disco precedente, la lunga "Living in the Heart of the Beast" recupera le sonorità tipiche dei primi lavori firmati Henry Cow, integrate dalla raffinata voce femminile. C'è nella musica qualcosa di più incombente, torbido a volte, che seduce l'ascoltatore, nonostante la voluta frammentarietà dell'impianto, gremito di pause e sincopi percussive, melodie trasversali, lunghe fughe ritmiche e violini dissonanti. La bella voce della Krause si fa più drammatica e teatrale in "Beautiful as the Moon - Terrible as an Army with Banners", scandito a dovere dal pianoforte, oppure affoga nel magma sonoro più estremo di episodi quali "Lovers of Gold", che sigilla l'intera sequenza nel suo imbuto claustrofobico. È sicuramente un altro album di spessore.L' ultimo disco di studio della formazione britannica arriva dopo quattro anni e s'intitola "Western Culture" (1979). Schierata a cinque senza la cantante, che abbandona nel 1977 per motivi di salute, e senza un bassista di ruolo, la band organizza una scaletta divisa in due parti intitolate "History & Prospects" e "Day by Day", scritte rispettivamente da Hodgkinson e da Lindasy Cooper. Fred Frith si cimenta anche con la chitarra acustica ("The Decay of Cities"), ma a dominare sono ancora i fiati (sax, clarinetto, oboe, fagotto, trombone) e il fitto lavoro percussivo di Cutler, spesso decisivo, come nell'iniziale "Industry". Bella l'atmosfera più pacata di "On the Raft", morbida bolla sonora che si dilata sui fiati, mentre nella seconda parte si fa notare il pianoforte dissonante di Irene Schweizer in "Gretel's Tale". Tuttavia è proprio lo splendido epilogo di "1/2 the Sky" che riassume magistralmente, tra virtuosismi di sax e una maestosa progressione sinfonica, la tensione ideale del gruppo.Una volta sciolta la band del calzino, bizzarra icona scelta per le copertine, Frith e Cutler, ancora insieme alla cantante tedesca, proveranno a portare avanti il discorso sotto la nuova sigla Art Bears, un progetto inaugurato già nel 1978 e discograficamente attivo fino ai primi anni Ottanta. Dischi consigliati: · Scheda Wikipedia Ricordato a volte solo per l'avventura coi i Gong di Daevid Allen, il chitarrista inglese Steve Hillage (Londra, 1951) è stato anche un solista di buona levatura e mai banale soprattutto, come ogni vero musicista di grande personalità. La sua carriera infatti è ricca di esperienze, imparentate spesso con la scena canterburiana, fin da quando giovanissimo fonda gli Uriel, band che poi, mutato il nome in Arzachel, registra un disco omonimo nel 1969.In seguito, studente universitario proprio a Canterbury, ha modo di suonare insieme alle più note band locali, finché nel 1971 rientra a Londra dove forma i Khan, meteora leggendaria che si scioglie dopo un solo disco. E' un periodo denso di incontri e collaborazioni di prestigio per il chitarrista, che tra l'altro collabora con Kevin Ayers ("Bananamour"). Infine entra stabilmente nei Gong nel 1973, in tempo per partecipare alla famosa trilogia del gruppo, dove il suo peculiare stile chitarristico s'impone come un punto di forza indiscutibile. Dopo che Allen ha lasciato il gruppo nelle mani di Pierre Moerlen, Hillage inizia un suo percorso solistico che di quella esperienza sembra voler raccogliere i frutti più maturi.  In effetti l'esordio di "Fish Rising", pubblicato nel 1975 dalla Virgin, rimane probabilmente il picco del chitarrista. Il disco si compone principalmente di tre suites, dove si respira ancora l'atmosfera fantasiosa che ruotava intorno al pianeta Gong (sono presenti quasi tutti i musicisti della trilogia), in una chiave di space-rock portato qui alla sua massima espressione: nella prima, "Solar Musick Suite", robuste pennellate di chitarra e tastiere (Dave Stewart) e synth lasciano il segno, in particolare nel segmento intitolato "Hiram Afterglid Meets The Dervish", un crescendo di tensione sul basso di Mike Howlett che culmina poi in un lungo solo acido di Hillage, ben affiancato dall'organo. Un gran pezzo davvero. "Aftaglid" risente di suggestioni più esotiche, con la sezione ritmica in grande spolvero accanto al lavoro solistico del leader ("The Great Wave and the Boat of Hermes" ad esempio), in un insieme fitto di pause affascinanti e strane cantilene di sapore ipnotico: impossibile poi non avvertire echi dei Gong nell'avvolgente finale di "The Golden Vibe/Outglide". L'altro pezzo forte è la suite più breve "The Salmon Song", col tagliente riff chitarristico incastonato nel gioco ritmico tiratissimo tra pause e riprese, mentre si riconosce nell'impasto anche l'oboe di Lindsay Cooper (Henry Cow). Hillage, voce solista nel disco, canta qui insieme alla compagna Miquette Giraudy, e fa valere la sua inconfondibile chitarra carica di effetti cosmici. Il secondo atto per Hillage è un album come "L" (1976), registrato a New York sotto l'ala produttiva del vulcanico Todd Rundgren, che coinvolge anche i musicisti del suo gruppo Utopia. La sequenza, che allarga lo spettro sonoro verso un rock più aperto e spesso melodico, allinea un paio di belle cover come "Hurdy Gurdy Man" di Donovan, in apertura, e "It's All Too Much", firmata da George Harrison per i Beatles di "Yellow Submarine", giusto in chiusura dell'album. Nel mezzo stanno quattro tracce vivaci e molto godibili, inclusa la terza cover di sapore mistico e atmosfera indiana come "Om Nama Shivaya", un famoso mantra Hindu, abilmente integrato però da vigorosi riff di chitarra elettrica e la voce in tono di Miquette Giraudy. In "Hurdy Gurdy Glissando", il leader suona anche la chitarra acustica tra percussioni esotiche e sonorità fusion avvolgenti, ma il picco sta forse nella lunga "Lunar Musick Suite", praticamente un seguito della suite solare del disco d'esordio: una composizione maestosa di grande effetto, segnata dallo stile chitarristico di Hillage tra le rullate poderose di John Wilcox, e impreziosita dalla tromba del noto jazzista Don Cherry. L'album è anche il più grande successo commerciale del chitarrista inglese.Nel 1977 Hillage fa uscire quindi "Motivation Radio", registrato a Los Angeles e composto di nove tracce di media durata, senza le lunghe suites del passato. Il suono è più diretto e sanguigno, fin dall'attacco di "Hello Dawn" o anche la brillante "Light in the Sky", cantata a due voci con Miquette: è interessante, soprattutto, l'approccio a un certo funk-rock elettronico senza complessi che caratterizza diversi brani, anche per la produzione di Malcom Cecil, rinomato esponente della Tonto's Expanding Head Band. Hillage canta con maggiore convinzione in brani come "Radio" e la più intrigante "Wait a Moment", traccia di gran classe articolata tra synth e chitarra, mentre "Searching for the Spark" è un episodio dalla ritmica tirata ancora dominato da synth avvolgenti e virtuosi effetti chitarristici. Si nota in ogni caso lo sforzo lodevole dell'artista di uscire da certi stilemi a costo di deludere i fans della prima ora: le vendite sono inferiori, ma il disco riceve giudizi molto positivi dalla critica più attenta. Tra i dischi che seguono il migliore è "Green", uscito nel 1978 e prodotto da Nick Mason dei Pink Floyd. Anche qui c'è il tentativo di traghettare le influenze space-rock verso sonorità più complesse, non sempre di facile assimilazione. Si ascolti "Musik of Trees", ad esempio, morbida canzone immersa tra spirali di synth e cantata a dovere dal chitarrista, con un finale evocativo. E' un album più ponderato e dalle molteplici sfumature strumentali, che si apre senza complessi a una ritmica funky come nel disco precedente ("Unidentified" o "U.F.O. Over "), ma in generale ancora più vario: ad esempio l'incipit rock ben cadenzato di "Sea Nature" o anche la fascinosa "Ether Ships", che cattura nelle sue atmosfere intriganti come il titolo, fino alla bella "Leylines to Glassoom", dove la chitarra lavora s'uno sfondo elettronico di grande effetto. Hillage suona nell'album una delle prime guitar synthesizer (Roland GR 500) che si caratterizza per un suono ibrido molto affascinante. A parte la più melodica e raffinata "Palm Trees (Love Guitar)", è a dir poco trascinante l'epilogo di "The Glorious Om Riff", con vaghi influssi orientali ben diluiti: il brano è articolato sul basso di Curtis Robertson ma con un gran lavoro anche del batterista Joe Blocker, naturalmente base ideale per la spumeggiante chitarra solista di Hillage.Sempre in cerca di nuovi stimoli, l'artista pubblica nel corso del 1979 ben tre dischi: uno è il doppio album "Live Herald", che mette insieme registrazioni dal vivo e anche una parte di studio con inediti: spicca tra questi "1988 Aktivator", brano vicino al punk-rock, un fenomeno che il chitarrista guardava con favore.Più spiazzante ancora è "Rainbow Dome Musick" che il chitarrista registra con la sola Miquette Giraudy: due lunghe suites sorprendenti, intrise di misticismo e dominate dall'elettronica, con la quasi totale assenza di percussioni. "Garden of Paradise", firmata dalla compagna di Hillage che la dedica allo "spirito universale" della New Age, è la più eterea, con sintetizzatori Arp e campane tibetane in evidenza, un po' di piano Fender e la chitarra elettrica che aggiunge note isolate al suggestivo flusso sonoro. "Four Ever Rainbow", composta da Hillage, non si discosta molto da questa cornice, che ricorda da vicino i corrieri cosmici tedeschi: oltre al moog, si ascolta la glissando guitar e ancora campane tibetane a scandire i venti minuti della composizione. Minimalista e in linea con i fermenti della "Nuova Era", è un disco che mantiene una sua coerenza interna, senza sbavature e ottiene un successo commerciale forse inatteso.  Meno convincente, tra influenze fin troppo diverse, è invece un album come "Open" (ancora '79), che mette insieme umori new wave, con qualche suggestione della ritmica dance e della new age ("Definite Activity" e "Day After Day") oltre a recuperare uno stile più melodico e lineare. Di buon effetto sono comunque "Earthrise", di atmosfera arabeggiante, e la solare "The Fire Inside", con un lungo solo chitarristico, ma il disco è spesso considerato la pagina più opaca del musicista.Il vero colpo di coda è una coppia di album che sterzano verso sonorità New Wave, suonati ancora con Miquette Giraudy: si tratta di "And Not Or" e quindi "For to Next", che la Virgin pubblica separati e poi riuniti come doppio album nel 1982. Nel primo dei due, che include sei tracce interamente strumentali, il largo uso di suoni sintetici convive con gli ottimi soli chitarristici di Hillage a carattere ipnotico, sulla base ritmica programmata: ad esempio l'apertura di "Before the Storm", tra i più esemplari di questa scelta. Alla lunga la sequenza può apparire monocorde, ma gli amanti dell'elettronica apprezzeranno di sicuro brani come l'incalzante "Serotonin" e soprattutto la stessa title-track, più atmosferica e arpeggiata, dove l'estro del chitarrista si fa comunque valere tra effetti variegati e piccole invenzioni solistiche nel lento crescendo del brano. Echi dello space-rock d'annata si ascoltano invece, ben diluiti, nella coda di "Knights Templar" e poi nell'epilogo del disco, "Still Golden". Le otto tracce di "For to Next" adottano invece la forma-canzone, sia pure con la stessa impostazione nei suoni, con Hillage impegnato anche al drum programming. Le parti cantate aggiungono indubbiamente un elemento di maggiore fruibilità: è un pop-rock ben incastonato nella nuova ondata sonora degli Ottanta, che però convince solo a tratti. Bella l'apertura di "These Uncharted Lands", soprattutto, e tra gli altri discreti "Alone", melodia a due voci con buone parti di chitarra, e anche "Anthems For the Blind". Il resto invece sembra appiattirsi sulla ritmica dance più banale e voci ripetitive, come "Frame By Frame" ad esempio, o "Kamikaze Eyes".In seguito, Hillage si ferma per dedicarsi soprattutto alla carriera di produttore. A sorpresa si riaffaccia però come musicista negli anni Novanta, con una nuova band chiamata System 7, prima di tornare a collaborare con i riformati Gong nel disco "2032", uscito nel 2009. Dischi consigliati: · Sito Ufficiale Non tutta la scena tedesca degli anni settanta era dedita alla cosiddetta 'musica cosmica' di gruppi famosissimi, quali ad esempio i Tangerine Dream e simili. Ne sono una dimostrazione appunto gli Hoelderlin, una band di ottimo livello, sicuramente più vicina al rock romantico e sinfonico di scuola inglese.Già nel 1972 la band fa il suo esordio con "Hoelderlin's traum", con una voce femminile, i testi ancora in tedesco, e una musica decisamente poco legata al resto del krautrock in voga. E' un prog-folk di eccellente fattura, dominato da delicate armonie ("Peter"), ma spesso immerso in atmosfere oniriche e sospese ("Requiem fur einen Wicht"), di notevole fascino e tensione, come la conclusiva "Traum". La voce di Nanny De Ruig non passa inosservata, come il prezioso tessuto strumentale prevalentemente acustico (viola, violoncello, flauti, chitarre, pianoforte), con qualche iniezione di mellotron. Le reazioni in Germania sono molto buone, ma dopo l'abbandono della cantante al termine di un intenso tour nel 1973, il gruppo è costretto a voltare pagina. Passano però tre anni prima che certe idee prendano compiutamente forma: l'album omonimo "Hoelderlin"(1975, a fianco), suona quasi come una seconda partenza, grazie anche alla produzione di Conny Plank. Come in precedenza la band è basata sui fratelli Christian (chitarre) e Joachim Grumbkow (tastiere, flauto, voce), con Christoph Noppeney (viola, chitarre, voce), Michael Bruchmann (batteria) e Peter Kaseberg(basso) a completare il quintetto. In realtà gli Hoelderlin restano uno di quei gruppi spesso aperti a collaborazioni diverse che ne arricchiscono il suono. I risultati del nuovo corso sono subito visibili nell'attacco strumentale di "Schwebebahn", raffinata divagazione per viola, piano e inserti di chitarra, in un clima che riecheggia i migliori King Crimson più maturi. Questo aspetto di sofisticato fusion-rock compare anche in "Honeypot", con il flauto in evidenza, innervata però da una morbida vena acustica e crepuscolare, e soprattutto nel lungo brano di chiusura, "Death-Watch-Beetle", oltre diciassette minuti che offrono un brillante saggio delle qualità di base del gruppo tedesco. Una buona capacità di orchestrare motivi diversi e intrecciati tra loro, a comporre un paesaggio sonoro prezioso e sempre mobile, tra classicismo sinfonico e spezzature più moderne, sempre temperate da un senso della misura che si direbbe il tratto caratteristico della band. I brani più brevi, come "I Love My Dog" (con un bel sax in primo piano) e soprattutto "Numberg", mostrano il rovescio più melodico e romantico degli Hoelderlin.
Nel successivo album "Clowns and Clouds"(1976, a fianco) la formazione si ripresenta con la sola variazione del bassista Hans Baar che rileva Kaseberg, e se possibile arricchisce ancora il proprio bagaglio espressivo. La musica si muove con la consueta eleganza, ma stavolta con minore discrepanza stilistica tra i pezzi, tutti improntati a un pop morbido e ritmicamente vario, con i soliti apporti esterni di sax (Jorg-Peter Siebert), come nell'apertura di "Madhouse", e la bella dimensione della viola di Noppeney nel successivo "Your eyes". Il momento più ambizioso del disco è però la suite centrale di "Circus", divisa in tre segmenti, tra marcette, accenni di tango e ripartenze guidate dall'organo di Joachim Grumbkow, con la voce solista multiforme e teatrale sulle orme di Peter Gabriel. Un certo eclettismo di toni e colori rimanda effettivamente ai Genesis, ma gli Hoelderlin possono annoverare come tratto distintivo una spiccata propensione a variazioni sul tema in stile fusion, con la viola sempre in grande spolvero nel cuore del pezzo in questione. Gli altri due titoli dell'album scivolano invece con bella disinvoltura verso una dimensione più liquida, con le tastiere e il flauto a duettare intorno al canto trasognato, e la chitarra elettrica a fare da morbido contrappunto prima del sax (la suggestiva "Streaming"). In "Phasing", che chiude la sequenza, i temi precedenti vengono come depurati e filtrati da archi, tastiere e flauto di grande eleganza, per poi evolvere dietro la batteria e il basso in una lunga coda immaginifica, a carattere prettamente sinfonico. Insieme al precedente, è probabilmente il disco più compiuto e riuscito degli Hoelderlin. Nel 1977 esce "Rare Birds"(a sinistra), che riconferma le qualità già espresse. Sono da segnalare un paio di cambiamenti nell'organico: Christian Grumbkow infatti fa un passo indietro e rimane autore dei testi, mentre cede la chitarra solista al nuovo Pablo Weeber.Musicalmente il disco non mostra particolari inversioni di tendenza: è ancora un solido prodotto, con una trama sonora ricca e sinfonica, piena di bei passaggi dominati dalla viola, dalle tastiere, e da più frequenti inserti di chitarra elettrica, in uno schema che si apre forse meno rarefatto e più intenso nell'approccio ritmico. L'esempio più eloquente è "Before you lay down rough and thorny", felicemente in bilico tra morbido pop d'atmosfera e vivaci spezzature 'fusion', che sembrano poi avere la meglio. Ancora una volta, però, il meglio viene dall'episodio strumentale: in questo caso "Necronomicron" (firmato dal nuovo Weeber), gotico e notturno andirivieni di chitarra e viola, tra improvvise pause e belle aperture di tastiere. Il brano posto in coda, "Sun rays", sembra quasi voler sintetizzare quest'ispirazione più sofisticata con la melodia morbida e sognante che emerge nella title-track, interpretata dalla delicata voce di Joachim Grumbkow. La fase migliore degli Hoerlderlin in pratica si chiude qui. Poi, con i dischi che seguono, tra i quali "New Faces"(1979) e "Fata Morgana"(1981), l'indirizzo stilistico della band si sposta verso un pop più melodico e meno collocabile nei confini del 'progressive'. Il loro nome, comunque, può tranquillamente essere citato come una delle migliori realtà 'sinfoniche' della scena rock tedesca. Dischi consigliati: · Sito MySpace Maestri riconosciuti dello Space Rock più estremo, farcito con pennellate di Hard Rock e Psichedelia, gli Hawkwind sono uno dei nomi più rispettati e longevi della scena musicale inglese. Nascono a Londra nel 1969 su iniziativa di Dave Brock, cantante oltre che chitarrista e tastierista, con altri elementi che si avvicendano rapidamente: fondamentale resta soprattutto l'incontro con il poliedrico fiatista Nick Turner, un vero pilastro di tutta la prima fase, e anche con Dik Mik (sintetizzatori), cui si aggiungono poi gli altri, tra i quali c'è il diciassettenne batterista Terry Ollis, reclutato con un annuncio sul "Melody Maker".  Stabilizzati finalmente come sestetto, spuntano un contratto con la United Artists che produce i primi sei dischi, in qualche modo tutti memorabili: se il primo della serie, l'omonimo "Hawkwind" uscito nel 1970, è un mezzo flop commerciale, segnala comunque una band che inaugura una formula sonora molto promettente e innovativa. Caratteristica del gruppo è già la cadenza ossessiva del basso (qui John Harrison) nell'iniziale "Hurry On Sundown", con il canto e l'armonica di Brock in evidenza, come pure in "Be Yourself", un lungo mantra scandito sulle chitarre, con inserti di synth e del sax di Turner, uniti alle rullate tribali di Ollis. E' la tipica trance sonora che fotografa uno stile che diverrà proverbiale. La psichedelia affiora soprattutto nelle due parti di "Paranoia", in un crescendo ansiogeno di suoni misteriosi, e ancora meglio nella lunga "Seeing It As You Really Are", tra voci lamentose, spirali di synth e riff chitarristici che risucchiano in un vortice malato senza liberazione. Ben adeguati al tono generale sono gli aspetti ruvidi, volutamente opachi della registrazione: anche questo un segno distintivo di Brock e soci, che rimarrà immutato nel tempo. Il successivo "In Search of Space" (1971) focalizza meglio, fin dal titolo, l'immaginario avventuroso del gruppo. Al basso Dave Anderson subentra a Johnson (instabile per l'abuso di droghe), ma la formula risulta rinvigorita già nell'attacco di "You Shouldn't Do That", debordante manifesto di hard rock cosmico, tirato senza tregua per sedici minuti su staffilate di sax, sintetizzatori, chitarre e batteria. I suoni elettronici sono a cura del nuovo Del Dettmar, un ingegnere del suono che affianca proficuamente Dik Mik. I sei episodi del disco scorrono tra paesaggi inusitati, liriche oniriche ("You Know You're Only Dreaming") al centro di trame ipnotiche e presagi inquietanti (la straniante melodia di "We Took The Wrong Step Years Ago"), in un flusso sonoro dove le chitarre, i suoni elettronici e i fiati sono ancora le colonne portanti, con isolate parentesi (la finale "Children of the Sun", col flauto e la chitarra acustica). Gli ingredienti di base in fondo sono semplici, meno intricati rispetto ad altre esperienze del Prog maggiore, ma l'iterazione ossessiva e circolare dei temi musicali ingenera alla lunga un effetto che stordisce e cattura nei suoi gorghi immaginosi: ecco il segreto di un altro brano celebre come "Master Of The Universe", ombelico della sequenza. Con il disco viene distribuito l'opuscolo "Hawklog", opera del poeta sudafricano Robert Calvert: è la base sulla quale gli Hawkwind svilupperanno il loro tipico spettacolo live, chiamato non a caso "Space Ritual". Intanto il singolo "Silver Machine" raggiunge i vertici della classifica inglese, mentre i lunghissimi concerti della band si guadagnano la fama di veri eventi, coinvolgenti come pochi altri. Il terzo disco "Doremi Fasol Latido", pubblicato nel 1972, segna l'ingresso in formazione del già noto bassista Lemmy Kilmister (già con Sam Gopal e in seguito leader dei Motörhead) e del nuovo batterista Simon King. Il rinnovato sestetto non cambia la formula ormai premiata dal pubblico e fin dall'apertura di "Brainstorm" si conferma in pieno la potenza sonora di questo rock anfetaminico e trascinante. "Space Is Deep", costruita sulle corde acustiche, si mette in scia cullato dai sintetizzatori, mentre "Lord of Light" e soprattutto "Time We Left This World Today", un rock pieno di spigoli che si ramifica sul refrain vocale ossessivo, si aggiungono alla galleria dei cavalli di battaglia della band inglese. L'apoteosi del momento di grazia è il doppio album live ovviamente intitolato "Space Ritual" (1973), vera consacrazione del suono-Hawkwind, che scorre inesausto per circa novanta minuti come un fiume in piena: è sicuramente tra i migliori dischi dal vivo dell'intero decennio e ancora oggi impressionante.Sempre nel 1973 Dik Mik fa un passo indietro, e così al gruppo si aggiunge il poliedrico tastierista e violinista Simon House (già con gli High Tide), sicuramente uno dei protagonisti dell'album "Hall of the Mountain Grill" (a destra), pubblicato nel 1974. Indubbiamente, a tratti, la musica si fa più sinfonica, come nella bella "Wind of Change", dove proprio il mellotron e il violino del nuovo arrivato guidano le danze. L'ispirazione è più varia, anche se non manca affatto il grande rock di marca-Hawkwind: magnifica ad esempio è "You'd Better Believe It", tiratissima dopo l'intro in sordina, con il tema circolare che trascina come un vento impetuoso dal ritmo battente, arricchito da violino e suoni sintetici. Convincenti, sullo stesso tenore, anche "D-Rider", sviluppato tra pieni e vuoti, e soprattutto l'apertura di "The Psychedelic Warlords (Disappear in Smoke)", con lunghi inserti al sax di Turner immersi nella trance ipnotica della sezione ritmica, mentre ancora un mellotron visionario insieme al pianoforte domina la breve title-track firmata da House.  Dopo questo importante capitolo, la band deve registrare però l'abbandono di Dettmar subito dopo il tour in Europa, mentre il percussionista Alan Powell entra in formazione per un disco come "Warrior On the Edge of Time" (1975). Si tratta stavolta di un vero concept ispirato all'idea del Campione Eterno che lo scrittore inglese Michael Moorcock sviluppò in molti suoi romanzi in stile fantasy. E' l'autore stesso, divenuto amico del gruppo, che recita in prima persona alcuni versi in due brani della sequenza, "The Wizard Blew His Horn" e "Warriors". Questa ispirazione unitaria, in ogni caso, dona al disco un alone ancora più fascinoso, nel quale anche il mellotron di House trova una perfetta collocazione: si ascolti ad esempio la meravigliosa sequenza iniziale "Assault and Battery/The Golden Void", immersa in una dimensione epica e risonante di scenari immaginifici. Alla fine l'album è un capolavoro assoluto, mescolando alla proverbiale impronta rock-psichedelica di Broke e soci (da "Opa-Loka" al travolgente rock di "Magnu" e "Kings of Speed", col violino aggiunto) una vena ancor più evocativa, a tratti sinfonica e più aperta a nuove suggestioni. Ogni episodio meriterebbe una citazione a parte, dalla stupenda ballata acustica "The Demented Man" allo strumentale "Standing at the Edge", dove elettronica e rock s'incontrano col supporto del flauto di Turner, con una capacità sorprendente di legare ogni frammento sonoro a un medesimo flusso emotivo che sgorga potente quanto ricco di sfumature. Un mosaico lirico-musicale davvero straordinario, che probabilmente è l'apice espressivo della band inglese.Il seguito invece è pieno di imprevisti: intanto l'irrequieto Lemmy, fermato alla frontiera canadese per droga (in realtà era anfetamina) viene allontanato e sostituito da Paul Rudolph, mentre il gruppo firma un nuovo contratto con la Charisma e cambia manager: come se non bastasse anche Nick Turner viene allontanato dopo la registrazione del nuovo disco, e questi mutamenti non sembrano giovare all'ispirazione.  In effetti "Astounding Sounds, Amazing Music", uscito nel 1976, suona meno esplosivo e per certi versi più ordinario del solito: oltretutto, le parti vocali sono affidate stavolta a un vecchio sodale come Robert Calvert, che fin dall'attacco di "Reefer Madness" in verità non convince troppo nel ruolo. Tra i sette brani alcuni lasciano interdetti come copie sbiadite del passato, mancando i fiati, e altri ancora dirottano il suono più riconoscibile della band in una direzione incerta, tra glam-rock e pop melodico non troppo originale: da "Steppenwolf" a "Kerb Crawler", ad esempio, con tanto di coretti femminili.Il nuovo corso si conferma anche col successivo "Quark, Strangeness and Charm" (1977, a destra), registrato con il nuovo bassista Adrian Shaw. Senza dubbio meglio focalizzato del precedente, con i testi visionari scritti da Calvert, è un disco che ha comunque buoni momenti: dalla lunga e ossessiva "Damnation Alley", che porta al proscenio il basso e le chitarre oltre all'organo, al rock arabeggiante di "Hassan I Sabha", sviluppato sul basso rombante di Shaw e il violino nel finale. Se l'incipit di "Spirit of the Age" è un'altra rock-song di buona presa col suo facile refrain, il canto di Calvert è in qualche caso fin troppo ammiccante, come nella title-track che ironizza su Albert Einstein. In fondo, la traccia più intrigante del lotto è la breve "The Forge of Vulcan", che House firma in solitudine: una parentesi di libertà espressiva tra organo e synth, più le percussioni, che forse avrebbe meritato maggiore spazio nella sequenza. La collaborazione con Michael Moorcock ha conosciuto in seguito altri capitoli, da "Sonik Attack", del 1981, a "The Chronicle of the Black Sword" (1985), mentre la formazione è cambiata spesso nel tempo secondo gli umori di Dave Brock, leader indiscusso della ditta. Per gli Hawkwind sembra lentamente affievolirsi il furore creativo della fase-United Artist, ma a questa vera istituzione del rock alternativo non è mai venuto meno l'affetto dei fans, mentre la produzione discografica, di studio e dal vivo, rimane ad oggi tra le più prolifiche e interessanti dell'intera scena britannica. Dischi consigliati: · Sito ufficiale Heldon è una creatura del chitarrista francese Richard Pinhas, che la forma nel 1974 a Parigi, dopo aver militato nel gruppo Schizo nei primi anni del decennio. Appassionato cultore di filosofia e fantascienza, il musicista battezza il suo nuovo progetto come il regno omonimo che lo scrittore americano Norman Spinrad inserisce nel romanzo ucronico "The Iron Dream" (tradotto in Italia come "Il signore della svastica"). Da notare che tutti i primi dischi vengono autoprodotti da Pinhas con la sua etichetta Disjuncta, per godere di una piena libertà artistica.  La discografia firmata Heldon, che spesso incrocia le prove solistiche del leader, deve molto all'elettronica e all'esperienza artistica dei King Crimson di Robert Fripp, del quale Pinhas eredita il peculiare stile chitarristico, pur inserendolo con personalità in architetture sonore del tutto originali. Se i risultati migliori di questo indirizzo, rigorosamente strumentale tranne sporadiche eccezioni, si ascoltano nei tardi Settanta, già l'esordio di "Électronique guérilla" (1974), che Pinhas dedica a Robert Wyatt, mostra le qualità del suono-Heldon. Suonato quasi in solitaria dal leader (synth e chitarre), con occasionali apporti esterni, è un album di elettronica a tutto campo come nella lunga "Back to Heldon", che mostra un lato dark e drammatico basato su spirali di sintetizzatore (AKS). Più assorta e meditativa è "Northerland Lady", dove Pinhas fa valere il suo raffinato stile chitarristico, con note prolungate di grande suggestione, mentre in "Circulus Vitiosus" il synth torna signore coi suoi giri ossessivi. In un brano come "Ouais Marchais, mieux qu'en 68" compare la voce del noto filosofo Gilles Deleuze, del quale Pinhas era studente, che legge la poesia "Il viandante e la sua ombra" di Friedrich Nietzsche.Il secondo album firmato Heldon "Allez Téia" (1975) è un omaggio esplicito a Robert Fripp: non a caso Pinhas ha dichiarato una volta che il maestro inglese è stato il suo Hendrix. Eloquente fin dal titolo l'attacco di "In the Wake of King Fripp", un seducente trionfo di mellotron e chitarre filtrate che richiama, amplificandola, la prima fase del Re Cremisi. Nel disco Pinhas si avvale soprattutto di Georges Grünblatt (già presente all'esordio), che suona anch'egli mellotron, synth e chitarra. Alcuni pezzi lasciano emergere la chitarra acustica, con echi spagnoleggianti a tratti: ad esempio "Aphanisis". Il tono della sequenza è generalmente sognante e umbratile, come nelle due parti di "Fluence", splendida davvero nel suo dilagare ininterrotto di onde elettroniche, e anche in "Omar Diop Blondin", che pure riporta la chitarra distorta del leader in primo piano. L'assenza di ogni elemento percussivo favorisce l'effetto immersivo nelle sonorità concepite da Pinhas, sempre di notevole effetto. La tappa successiva è il doppio album "It's Always Rock'n'Roll", anche detto "Heldon Third" (ancora 1975), che prosegue coerentemente nella stessa scia dei precedenti, ma con qualche ombra in più. Episodi di space-rock come "Cotes de cachalot à la psylocybine" danno il senso della ricerca di Pinhas: il mellotron di Grünblatt affianca il leader in questa galoppata dalla scansione ipnotica. Nella sequenza si segnala "Méchamment rock", che vede la batteria di Gilbert Artman (dei Lard Free) scandire un brano più breve, segnato dalle scariche elettriche e involute del chitarrista, mentre "Cocaine Blues" è un'escursione cosmica ridondante. A volte, in verità, il disco soffre di una certa ripetitività, e lunghe derive come "Aurore" (con l'harmonium indiano di Ariel Kalma) e quindi la conclusiva "Doctor Bloodmoney", dove Patrick Gautier suona il synth ARP, sebbene interessanti al pari della crimsoniana "Ocean Boogi" (firmata da Grünblatt), nel complesso sembrano segnare un momento di stasi nell'ispirazione. Pinhas però insiste con "Agneta Nilsson" (1976), che prosegue il discorso senza troppi tentennamenti e alcune novità. Nelle quattro parti di "Perspective" l'atmosfera si carica di tensione con inserti di synth sullo sfondo, in un clima che ricorda molto i corrieri cosmici tedeschi: in "Perspective I" domina comunque il mellotron di Philibert Rossi, mentre "Perspective III" pulsa inesausta secondo uno schema che incorpora effetti speciali e distorsioni della prediletta Gibson Les Paul del leader. A parte la breve parentesi di "Intermède & Bassong", dove interviene il bassista Gerard Prevost degli Zao, l'ombelico dell'album è indubbiamente la lunghissima "Perspective IV", ben ventuno minuti che includono il minimoog di Patrick Gauthier, nuovi effetti di chitarra e per una volta anche batteria e percussioni (Coco Roussel), in un insieme più complesso che sembra anticipare le prove a venire più rinomate: un Avant-Prog maturo, che abbandona in parte le influenze crimsoniane più superficiali per acquisire consapevolezza.Lo si nota nella discografia che segue, a cominciare da "Un rêve sans conséquence spéciale", uscito nel 1976: fin dall'attacco della futuristica "Marie Virginie C.", una prolungata distorsione che ingloba chitarra, moog, basso e soprattutto la batteria impressionante di François Auger, la musica slitta in una dimensione industriale del tutto inedita per Heldon. Le percussioni rutilanti sono pure il perno di "Elephanta", traversata da scie traccianti di synth, ma il punto focale, più ancora del lungo epilogo di "Toward the Red Line", è probabilmente un brano come "MVC II", tra suoni metallici e cadenze involute, una sorta di incubo senza uscita che cattura nella sua meccanica ridondante.  Gli ultimi due capitoli rappresentano l'apice di questa ricerca: avanguardia, psichedelia elettronica e musica industriale confluiscono nei due veri capolavori firmati Heldon. "Interface" (1977), il primo, consolida un gruppo di lavoro che include Patrick Gauthier (minimoog e moog bass) e il formidabile batterista François Auger accanto al leader. Su basi ritmiche affilate e spesso travolgenti che circoscrivono il perimetro, la chitarra solista di Pinhas trova il suono più graffiante dell'epoca: prima "Jet Girl", poi "Bal-à-fou", con il basso di Didier Batard co-protagonista, infine la title-track sono un crescendo di tensione scandito con rara coerenza da cima a fondo. Nell'epilogo le percussioni avanzano a lungo pulsanti e minacciose, prima che una chitarra elettrica davvero torturata incida il suo marchio sull'insieme, chiuso a sorpresa da un estemporaneo accenno di rock'n'roll: come se gli estremi si toccassero per pochi secondi. E' un album dal suono compatto e lacerante che lascia il segno: sempre rimarchevole la performance del batterista, oltre che del moog poliedrico di Gauthier.Nello stesso anno Pinhas pubblica "Rhizosphere", il primo di una lunga serie di album da solista, ma nel 1979 si chiude intanto la fase maggiore degli Heldon, che avrà una tarda appendice solo nel 2001 ("Only Chaos is Real"). Lo splendido "Stand By" è infatti sullo stesso livello del precedente, se non superiore, e corona nel modo migliore la parabola del gruppo. Anche in piena era punk, il chitarrista francese resta fedele al suo progetto, senza nessun cedimento alle mode del momento. La prima parte è costituita dagli otto segmenti di "Bolero", una cavalcata superba di oltre venti minuti dove la chitarra solista, la batteria e il minimoog procedono in perfetta simbiosi, con il gran lavoro del bassista Didier Batard nello sviluppo e la voce filtrata di Klaus Blasquiz (dei Magma) aggiunta qua e là a rifinire l'insieme. Più breve e dinamica è una traccia come "Une drole de journée", dominata dal moog e le ricche tastiere di Gauthier, incluso il piano. E' solo una parentesi, però, prima del vero atto finale costituito dalla title-track: un possente rock elettronico dai tratti quasi epici, con la chitarra solista di Pinhas più tagliente che mai sugli scudi, in un impasto vibrante, ad alta gradazione, dove la batteria di Auger fa ancora la differenza. E' quasi un orgoglioso, magnifico canto del cigno, specie nell'ultima parte: il degno suggello di un decennio esplosivo, ormai agli sgoccioli, e soprattutto di un percorso artistico tra i più affascinanti nella storia del rock francese. Dischi consigliati: · Sito ufficiale di Richard Pinhas
Nati ad Heidelberg nel 1967 su iniziativa del batterista Mani Neumeier (che in precedenza suonava free-jazz), i tedeschi Guru Guru sono un gruppo dalla vasta discografia che ha spesso mandato in confusione critica e pubblico per una musica che non è facilmente etichettabile, seppure di grande impatto. La band all'inizio era parte di una vera "comune" alternativa e ha trascorso anni di vita nomade, ospite di amici e fans: popolari soprattutto per i loro concerti anarchici e coinvolgenti, hanno venduto nel tempo oltre mezzo milione di dischi, che non è poco per musicisti così poco inclini al compromesso nonché politicamente schierati . Già l'esordio di  Nella stessa scia si pone il successivo "Hinten" (1971): quattro tracce ancora dirompenti e creative, a cominciare da "Electric Junk" ("spazzatura elettrica"), titolo che è già un programma. Qui l'underground sempre più estremo del trio fa un passo ulteriore e l'apparente immediatezza si fa avanguardia sonora e concettuale. C'è da restare ammirati, in generale, per come tre soli strumentisti sappiano dar vita a una musica così piena di risonanze, effetti, atmosfere anche complesse, di sicuro sempre inconsuete. Le percussioni variegate di Neumeier (gong, batteria elettronica, kalimba, cimbali, ecc.) più le inventive distorsioni chitarristiche di Genrich insieme al basso di Trepte, compongono anomali manifesti di psichedelia disturbante, ma perfettamente dentro un tempo fatto di interferenze e segnali obliqui, con voci alterate a condire il tutto. Soprattutto "The Meaning of Meaning" sembra davvero indugiare dietro le quinte della civiltà urbana e industriale, restituendone suoni, umori e atmosfere spigolose, mentre il resto è comunque originale: il rock and roll ironico e destrutturato di "Bo Diddley", per cominciare, e poi la fantasia cosmica di "Space Ship", tutto meno che un'armoniosa escursione siderale, come nei più noti corrieri cosmici di quegli anni. Tra pause e percussioni martellanti, invece, si aprono qui squarci d'improvvisazione che fanno la differenza e portano l'ascoltatore fuori dalle formule più riconoscibili, in territori ancora inesplorati. La formula si ripete anche in "Kanguru", pubblicato nel 1972 con la produzione del noto Conny Plank, anche se il trio sceglie modalità appena meno respingenti e più fruibili. Questo dà modo di apprezzare meglio le qualità dei singoli, fin dall'ipnotica "Oximoron", che ruota intorno alla chitarra solista di Genrich, sostenuta ad arte dalle percussioni e dal basso in un lento crescendo piuttosto raffinato, senza forzature, con vocalizzi sparsi qua e là. "Baby Cake Walk" è un altro rock tirato tra cambi di tempo e riprese, scandito da rullate poderose di batteria, ma con una cesura improvvisa sul basso che prepara il torrido finale chitarristico. In "Immer Lustig" (cioè "sempre divertente"), la traccia più lunga coi suoi quindici minuti e passa, prevale all'inizio un clima circense, introdotto da un enfatico annuncio, e sviluppato poi nella consueta jam guidata dalla chitarra torturata di Genrich, abilmente sostenuta da una sezione ritmica creativa e pulsante, sempre fantasiosa: è un suono ogni volta caldo e imprevedibile, tra pieni, vuoti ed echi misteriosi, che racchiude la cifra più vera del gruppo tedesco. La conferma arriva dall'epilogo di "OOga Booga", un multiforme rock psichedelico coniugato a canti esotico-rituali e percussioni tribali da situarsi all'incrocio di influenze diverse, ben tenute insieme dalla chitarra solista.Più altalenante il seguito discografico, ma con qualche bella impennata che dimostra la caratura del trio. Il quarto album della band, ad esempio, è "Guru Guru" (1973), inciso con il nuovo bassista Bruno Schaab. Più diretto e meno oscuro del solito, il disco offre un corposo richiamo al rock'n'roll più classico nel lungo "Medley", sorta di sentito omaggio a Eddie Cochran, una leggenda del rockabilly americano, con tanto di gridolini e riff chitarristici in serie. Se qualche episodio appare più ordinario (come "Woman Drum"), la verve del trio si palesa comunque nella lunga coda di "Story of Life", ma il pezzo forte di una sequenza che vive di luci e ombre è indubbiamente "Der Elektrolurch" (cioè "l'anfibio elettrico"). Segnata da un pirotecnico lavoro alla chitarra di Genrich, la composizione si articola tra ritmi saltellanti e imprevedibili cesure, fino a una seconda parte scandita dal basso, con scariche elettriche che creano tensione e liriche parlate s'una base sempre mutevole. Il pezzo diventa un vero cavallo di battaglia del gruppo negli shows, abilmente interpretato da Mani coi suoi fantasiosi travestimenti in tema.
Dei successivi dischi, molti dei quali restano comunque degni di nota, il migliore sembra "Dance of the Flames" (1974), il primo pubblicato dai Gurus senza la chitarra di Ax Genrich. Molto bella e trascinante l'apertura di "Dagobert Duck's 100th Birthday", con la chitarra solista di Houschäng Nejadépour (ex Eiliff) sugli scudi con un riff che lascia il segno insieme al basso, tra le impetuose rullate di Mani. Lo schema si ripete con "The Girl From Hirschorn", con la cadenza inesausta della batteria e del basso, e il chitarrista ancora vivace protagonista, anche all'acustica nella seconda parte, con melodiche parti vocali del batterista. Altrove si colgono perfino echi fusion modello Mahavishnu Orchestra: è il caso di brani strumentali come la title-track e poi "The Day of Timestop", sempre con un'alta tensione ritmica e basso e chitarra in grande spolvero. Nejadépour è il protagonista indiscusso delle prime quattro tracce, con uno stile che sposta la musica del gruppo dalla psichedelia esplosiva degli inizi verso uno stile più aperto che ingloba suggestioni variegate, fino alla tradizione brasiliana in "Samba das rosas": sorprendente. Nella seconda parte, comunque più pacata, le percussioni tornano protagoniste ("Rallulli") come la chitarra acustica ("At the Juncture of Light and Dark"), ma il cerchio si chiude con la progressione vagamente sinistra di "God's Endless Love For Men", degno epilogo di un album ricco di pagine vibranti. La parabola migliore e più rinomata della band si arresta qui. Già nel successivo "Mani und seine freund" (1975), il leader cambia tutto con un gruppo aperto e l'introduzione in organico di fiati e tastiere: il risultato è un jazz-rock-funky dalle risonanze etniche e anche melodiche ("Chicken Rock"), a volte troppo facile, seppure alternato a un paio di tracce fusion più consistenti ("It's Your Turn" soprattutto), con una verve ancora apprezzabile ma lontana dai picchi espressivi degli inizi. Grazie all'inossidabile spirito creativo di Mani Neumeier, leader incontrastato, non mancheranno tuttavia altri dischi interessanti, e tra inevitabili alti e bassi (specie negli Ottanta) i Guru Guru restano comunque uno dei nomi più importanti, anzi seminali, della pur ricca scena underground tedesca. Dischi consigliati: · Sito ufficiale |









 Quanto a
Quanto a  E' un vero peccato, perché in realtà
E' un vero peccato, perché in realtà 








 Anche l'altro album uscito nel '73,
Anche l'altro album uscito nel '73, 