
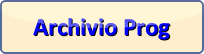
 Laboratorium
Laboratorium  Lady Lake
Lady Lake  Lard Free
Lard Free  Laser
Laser  Latte e Miele
Latte e Miele  Lava
Lava  I Leoni
I Leoni
 Franco Leprino
Franco Leprino  Libra
Libra  Life (SWE)
Life (SWE)  Life (UK)
Life (UK)  Light
Light  Lightshine
Lightshine  Lily
Lily  Living Life
Living Life  Living Music
Living Music  Lucifer's Friend
Lucifer's Friend
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
In gran parte dell'Europa orientale, ma soprattutto in Polonia, il jazz ha avuto un grande sviluppo perché meno "sospetto" per i regimi socialisti rispetto al rock, ma i Laboratorium, nati a Cracovia nel 1970, sono stati capaci di aprire il jazz a sonorità più moderne, in un modo che ha fatto scuola. La band si fa notare in molti festival internazionali (Zurigo, San Sebastián, Mumbai) prima di realizzare dischi. Se "Klub Płytowy - Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego" (1973) è un album collettivo dove i Laboratorium suonano due sole tracce insieme al violinista Zbigniew Seifert, il primo vero disco della band è "Modern Pentathlon" (1976). Capeggiato da Janusz Grzywacz (piano e synth), il quintetto si produce in una fusion poco accademica, come nella lunga suite del titolo: tra percussioni e synth, prende corpo un jazz-rock astratto, con i fiati di Marek Stryszowski (sax e clarinetto) a intessere trame evocative sulla raffinata base ritmica, mentre il piano elettrico di Grzywacz si fa sentire con misura, tra i vocalizzi del fiatista. E' da rimarcare, in tutta la suite, il dinamico lavoro congiunto del bassista Krzysztof Ścierański e del batterista Mieczysław Górka, sia nei momenti più melodici che in quelli più rarefatti. Se questo è l'ombelico dell'album, non è da meno il resto, anche se più immediato: ad esempio "Funky for Franka", vivace funky-jazz con piano elettrico e sax protagonisti nel brioso schema ritmico, o la scoppiettante "ABZ", che a tratti richiama il Perigeo, fino a "Crazy Shepherd", col motivo del sax a guidare le danze, tra vocalizzi esotici e il basso sempre creativo. Il disco registra ottime vendite, e i Laboratorium fanno uscire "Aquarium Live" (1977), registrato nell'omonimo club di Varsavia: è una sequenza di lunghe improvvisazioni ("Struktura Przestrzeni") e brani più originali, come "Flamenco Na Miękko", con chitarra e sax travolgenti tra breaks percussivi di sapore esotico. Dopo "Diver" (1978), è quindi la volta di "Quasimodo" ( ), pubblicato nel 1979: è probabilmente il miglior disco del gruppo, composto da quattro brani più lunghi e altrettanti più brevi come introduzioni: ad esempio "Etiudka", per solo pianoforte, e "Kyokushinkay", improvvisazione tra la chitarra di Paweł Ścierański e le percussioni. Il picco sta forse nella title-track, cullata inizialmente dal basso, con il piano elettrico e la chitarra in sordina, fino alla frase al sax di Stryszowski che punteggia il tema: è un jazz-rock di gran classe, che spiega la fama che circonda la band, considerata un po' la risposta polacca ai celebri Weather Report. Richiami al gruppo americano si avvertono anche in "I'm Sorry, I'm not a Driver", con vocalizzi atmosferici in un clima di felpato jazz venato di funky e il basso in bella evidenza insieme alle chitarre, acustica ed elettrica. Contagioso e incalzante il tema di "Śniegowa panienka" (cioè "la fanciulla di neve"), poi innervato nella parte centrale da un sax in stato di grazia e dal piano sempre raffinato di Grzywacz, mentre l'epilogo di "Ikona" è un omaggio allo scomparso Zbigniew Seifert. In seguito, il gruppo realizza altri dischi in una formazione diversa, con i soli Grzywacz e Stryszowski del primo nucleo: ad esempio "No. 8" (1984) e poi "Anatomy Lesson" nel 1986, ma la storia finisce intorno al 1990. Il pianista rimane molto attivo, e scrive musiche per cinema e teatro, realizzando anche un paio di album solisti. Ristampe in CD a cura di Metal Mind e Polskie Nagrania Muza. ), pubblicato nel 1979: è probabilmente il miglior disco del gruppo, composto da quattro brani più lunghi e altrettanti più brevi come introduzioni: ad esempio "Etiudka", per solo pianoforte, e "Kyokushinkay", improvvisazione tra la chitarra di Paweł Ścierański e le percussioni. Il picco sta forse nella title-track, cullata inizialmente dal basso, con il piano elettrico e la chitarra in sordina, fino alla frase al sax di Stryszowski che punteggia il tema: è un jazz-rock di gran classe, che spiega la fama che circonda la band, considerata un po' la risposta polacca ai celebri Weather Report. Richiami al gruppo americano si avvertono anche in "I'm Sorry, I'm not a Driver", con vocalizzi atmosferici in un clima di felpato jazz venato di funky e il basso in bella evidenza insieme alle chitarre, acustica ed elettrica. Contagioso e incalzante il tema di "Śniegowa panienka" (cioè "la fanciulla di neve"), poi innervato nella parte centrale da un sax in stato di grazia e dal piano sempre raffinato di Grzywacz, mentre l'epilogo di "Ikona" è un omaggio allo scomparso Zbigniew Seifert. In seguito, il gruppo realizza altri dischi in una formazione diversa, con i soli Grzywacz e Stryszowski del primo nucleo: ad esempio "No. 8" (1984) e poi "Anatomy Lesson" nel 1986, ma la storia finisce intorno al 1990. Il pianista rimane molto attivo, e scrive musiche per cinema e teatro, realizzando anche un paio di album solisti. Ristampe in CD a cura di Metal Mind e Polskie Nagrania Muza.
|
"Quasimodo"
|
||||||||
Questo gruppo originario di Deventer, in Olanda, si forma nel 1973 e si fa conoscere localmente con la sigla Session nelle sue apparizioni dal vivo. Questa fase iniziale si chiude nel giro di un solo anno, ma nel 1976 il tastierista Leendert Korstanje, ex Delay, incontra il chitarrista Fred Rosenkamp, membro del primo nucleo, e insieme rilanciano il progetto: è questa la nascita ufficiale dei Lady Lake, nome ispirato dal titolo di un noto disco degli inglesi Gnidrolog. Solo nel 1977, stabilizzati come quartetto, i Lady Lake realizzano l'album "No Pictures" ( ). A parte un paio di pezzi cantati dall'ospite Stanley Dijkhuis, come "You Make Me Feel So Fine", l'aspetto strumentale è sicuramente quello che cattura l'attenzione nelle otto tracce. L'influsso più evidente è senza dubbio il prog sinfonico-romantico di maestri come Genesis e simili, senza dimenticare i connazionali Focus, ma in generale i Lady Lake sanno personalizzare la formula con una certa eleganza di scrittura, come nella suite in tre parti "Between Bremen and Hamburg": se "Part 1", con una bella chitarra blues in evidenza, è l'altro episodio cantato del disco, nella raffinata "Part 2" la chitarra acustica di Rosenkamp crea un'atmosfera sognante di buon effetto insieme al pianoforte, mentre il terzo segmento è un dinamico quadro fusion dal ritmo più vivace che lascia emergere la chitarra solista, oltre al synth di Leenderd Korstanje. Se questo è forse il momento più fine della sequenza, il resto non sfigura affatto: il synth connota pezzi interessanti come l'attacco di "Cornwall", ben scandito dalla batteria di Joop Van Leeuwen, anche qui con inserti accattivanti della chitarra acustica in un impasto costellato di breaks, ma il resto è dominato dalle chitarre. Un valido esempio è la breve "No More Gentle Treatment", con Rosenkamp che sforna soluzioni pirotecniche in uno schema ritmico intenso, come pure avviene in "Magic Twanger", tra pause e ripartenze continue e il piano a supporto: in buona evidenza qui anche il basso di Eddy Bakker. L'influenza del gruppo di Peter Gabriel si fa sentire soprattutto in un episodio come "Fading Trees", col suo crescendo ritmico pieno di coloriture del synth e riff in serie della chitarra solista, prima di sfumare nel più arioso finale per piano e chitarra acustica. Senza essere un capolavoro, "No Pictures" si guadagna certamente un posto d'onore tra le proposte di un genere che nella seconda metà dei Settanta declina rapidamente, e si fa ascoltare ancora oggi con interesse, regalando qualche sorpresa. Pur suonando ancora dal vivo, la band olandese si scioglie infine nel 1982, ma periodicamente è tornata attiva: a parte "Unearthed" (2006), che porta alla luce il secondo album mai realizzato all'epoca, sono usciti nuovi dischi quali "SuperCleanDreamMachine" (2005) e più avanti "Not Far From Llyn Llydaw" (2022). Ristampe in CD, con diversa copertina e bonus-tracks, a cura di Musiphyle e MALS. ). A parte un paio di pezzi cantati dall'ospite Stanley Dijkhuis, come "You Make Me Feel So Fine", l'aspetto strumentale è sicuramente quello che cattura l'attenzione nelle otto tracce. L'influsso più evidente è senza dubbio il prog sinfonico-romantico di maestri come Genesis e simili, senza dimenticare i connazionali Focus, ma in generale i Lady Lake sanno personalizzare la formula con una certa eleganza di scrittura, come nella suite in tre parti "Between Bremen and Hamburg": se "Part 1", con una bella chitarra blues in evidenza, è l'altro episodio cantato del disco, nella raffinata "Part 2" la chitarra acustica di Rosenkamp crea un'atmosfera sognante di buon effetto insieme al pianoforte, mentre il terzo segmento è un dinamico quadro fusion dal ritmo più vivace che lascia emergere la chitarra solista, oltre al synth di Leenderd Korstanje. Se questo è forse il momento più fine della sequenza, il resto non sfigura affatto: il synth connota pezzi interessanti come l'attacco di "Cornwall", ben scandito dalla batteria di Joop Van Leeuwen, anche qui con inserti accattivanti della chitarra acustica in un impasto costellato di breaks, ma il resto è dominato dalle chitarre. Un valido esempio è la breve "No More Gentle Treatment", con Rosenkamp che sforna soluzioni pirotecniche in uno schema ritmico intenso, come pure avviene in "Magic Twanger", tra pause e ripartenze continue e il piano a supporto: in buona evidenza qui anche il basso di Eddy Bakker. L'influenza del gruppo di Peter Gabriel si fa sentire soprattutto in un episodio come "Fading Trees", col suo crescendo ritmico pieno di coloriture del synth e riff in serie della chitarra solista, prima di sfumare nel più arioso finale per piano e chitarra acustica. Senza essere un capolavoro, "No Pictures" si guadagna certamente un posto d'onore tra le proposte di un genere che nella seconda metà dei Settanta declina rapidamente, e si fa ascoltare ancora oggi con interesse, regalando qualche sorpresa. Pur suonando ancora dal vivo, la band olandese si scioglie infine nel 1982, ma periodicamente è tornata attiva: a parte "Unearthed" (2006), che porta alla luce il secondo album mai realizzato all'epoca, sono usciti nuovi dischi quali "SuperCleanDreamMachine" (2005) e più avanti "Not Far From Llyn Llydaw" (2022). Ristampe in CD, con diversa copertina e bonus-tracks, a cura di Musiphyle e MALS.
|
"No Pictures"
|
||||||||
Importante formazione francese di Avant-Prog, messa insieme a Parigi sul finire del 1970 dal batterista Gilbert Artman, che si unisce a Hervé Eyhani (basso), Francois Mativet (chitarra) e Philippe Bolliet (sax) per il primo disco omonimo, uscito nel 1973. E' una sequenza interamente strumentale, che coniuga psichedelia ed elettronica a sfumature jazz, in un impasto di buona suggestione. Una chitarra elettrica torturata, alla maniera di Fripp, si avventura in lunghe derive frantumate dalla ritmica irregolare, con affilati soli di sax ("12 ou 13 juillet que je sais d'elle" e l'iniziale "Warindbaril"), spesso con effetti marcatamente dark ("Acide framboise"). Ci sono isole di suoni rarefatti, col vibrafono in evidenza insieme a sax e basso ("Livarot respiration"), e soprattutto una ricerca continua di sonorità in costante divenire, che nulla concedono alle formule rock più facili. Un esordio autorevole, vicino a certe coeve esperienze della musica tedesca più sperimentale. Il discorso prosegue nel successivo "I'm Around About Midnight" (1975) , con Artman che rivoluziona la band: al posto dei partenti entrano il noto chitarrista/bassista Richard Pinhas (del gruppo Heldon), e ben due fiatisti come Alain Audat e Antoine Duvernot. Sviluppando le premesse del primo album, il suono si spinge ora in audaci territori che possono anche richiamare, a tratti, il Mike Oldfield degli inizi: ad esempio "Does East Bakestan Belong To Itself", col flauto di Duvernot e le percussioni del leader in primo piano. I corposi effetti elettronici evocano spazi diversi e affascinanti, come nell'iniziale "Violez l'espace de son refrigerant", tra richiami di matrice cosmica, e quindi "In a Desert-Alambic", scandito da ossessive percussioni tribali e linee ondivaghe di chitarra punteggiate dai fiati. Il brano più lungo della raccolta, "Tatkooz a Roulette", cresce s'un organo avvolgente e rintocchi evocativi, prima che il synth salga al proscenio in lunghe variazioni. "Pale Violence Under a Reverbere" recupera il suono più corposo di chitarra e batteria in una scansione oscura e incombente, traversata da lampi sinistri, mentre il pianoforte classico di Artman domina la conclusiva "Even Silence Stops When Trains Come", che si spegne tra effetti disturbanti e spirali di vento. Il terzo e ultimo disco firmato Lard Free si chiama semplicemente "III" (1977) e avvicina ulteriormente il suono della band francese ai cosmici teutonici. Basta ascoltare la lunga "Spirale Malax" iniziale, dominata da organo e suoni sintetici ossessivi in espansione lineare, con il tribalismo percussivo aggiunto nella seconda parte oltre a crudi inserti di chitarra del nuovo arrivato Xavier Baulleret. Oltre a lui, con Artman ci sono adesso il clarinettista Jean-Pierre Thiraut e Yves Lanes ai sintetizzatori. L'altra suite in tre parti, non a caso è intitolata "Synthetic Seasons": nel reticolo sintetico trovano comunque più spazio la chitarra e le ritmiche, nel secondo e soprattutto nel terzo segmento, dove la trama procede ancora più inquietante, tra sincopi e distorsioni di vario tipo. E' musica tetra, ostica e nel suo genere molto rigorosa. La stesso anno Artman registra il primo di una lunga serie di album con il nuovo progetto Urban Sax, ponendo fine di fatto all'esperienza dei Lard Free. In seguito ha visto la luce anche "Unnamed" (1997), con registrazioni inedite del periodo 1971-'72. Ristampe Spalax, Wah-Wah Records Sound e Captain Records. , con Artman che rivoluziona la band: al posto dei partenti entrano il noto chitarrista/bassista Richard Pinhas (del gruppo Heldon), e ben due fiatisti come Alain Audat e Antoine Duvernot. Sviluppando le premesse del primo album, il suono si spinge ora in audaci territori che possono anche richiamare, a tratti, il Mike Oldfield degli inizi: ad esempio "Does East Bakestan Belong To Itself", col flauto di Duvernot e le percussioni del leader in primo piano. I corposi effetti elettronici evocano spazi diversi e affascinanti, come nell'iniziale "Violez l'espace de son refrigerant", tra richiami di matrice cosmica, e quindi "In a Desert-Alambic", scandito da ossessive percussioni tribali e linee ondivaghe di chitarra punteggiate dai fiati. Il brano più lungo della raccolta, "Tatkooz a Roulette", cresce s'un organo avvolgente e rintocchi evocativi, prima che il synth salga al proscenio in lunghe variazioni. "Pale Violence Under a Reverbere" recupera il suono più corposo di chitarra e batteria in una scansione oscura e incombente, traversata da lampi sinistri, mentre il pianoforte classico di Artman domina la conclusiva "Even Silence Stops When Trains Come", che si spegne tra effetti disturbanti e spirali di vento. Il terzo e ultimo disco firmato Lard Free si chiama semplicemente "III" (1977) e avvicina ulteriormente il suono della band francese ai cosmici teutonici. Basta ascoltare la lunga "Spirale Malax" iniziale, dominata da organo e suoni sintetici ossessivi in espansione lineare, con il tribalismo percussivo aggiunto nella seconda parte oltre a crudi inserti di chitarra del nuovo arrivato Xavier Baulleret. Oltre a lui, con Artman ci sono adesso il clarinettista Jean-Pierre Thiraut e Yves Lanes ai sintetizzatori. L'altra suite in tre parti, non a caso è intitolata "Synthetic Seasons": nel reticolo sintetico trovano comunque più spazio la chitarra e le ritmiche, nel secondo e soprattutto nel terzo segmento, dove la trama procede ancora più inquietante, tra sincopi e distorsioni di vario tipo. E' musica tetra, ostica e nel suo genere molto rigorosa. La stesso anno Artman registra il primo di una lunga serie di album con il nuovo progetto Urban Sax, ponendo fine di fatto all'esperienza dei Lard Free. In seguito ha visto la luce anche "Unnamed" (1997), con registrazioni inedite del periodo 1971-'72. Ristampe Spalax, Wah-Wah Records Sound e Captain Records.
|
"I'm Around About Midnight" |
||||||||
| Di questo gruppo di origine romana sappiamo abbastanza poco. Formato alla fine degli anni Sessanta come Il Laser, incide un primo 45 giri nel 1972 e quindi, dopo qualche avvicendamento, il rinnovato quintetto realizza l'unico album di cui si ha notizia, poi riedito su CD da Mellow Records e Akarma: "Vita sul pianeta" (1973). La musica della band, che cerca un equilibrio tra passaggi rock e melodia tipicamente italiana, è in ogni caso insoddisfacente, povera di soluzioni originali nell'accoppiata organo/chitarra (Valentino D'Agostino e Loris Cardinali) che scandisce senza troppa fantasia gli otto brani in scaletta, con titoli già di per sé eloquenti come "Dove andremo?" e "L'ultimo canto del killer", dove si ascolta anche il falsetto. Fin dall'attacco della title-track, con qualche spunto vivace di chitarra elettrica e coretti stucchevoli, il disco sembra avere un'impostazione concept, secondo la moda del tempo: la vita che si evolve, appunto, sulla terra in modi e forme diverse. Niente di nuovo sotto il sole, insomma, e comunque le liriche sono fin troppo retoriche, o naive, per destare un vero interesse: come se non bastasse, anche le voci che si alternano nei singoli brani, in mancanza di un vero cantante di ruolo, sono tutt'altro che brillanti nell'espressione dei contenuti ("Non vede la gente", ad esempio), lasciando un sapore di approssimazione che certo non giova all'effetto complessivo. Non che i singoli componenti della band manchino di qualità, ma è proprio l'insieme, frammentario nella scrittura e poco accurato a livello di produzione, a penalizzare anche i momenti potenzialmente interessanti della sequenza. In estrema sintesi, "Vita sul pianeta" è un album decisamente modesto, che all'epoca passa praticamente inosservato anche per la scarsa promozione garantita dall'etichetta Car Juke Box, e il gruppo finisce per sciogliersi poco dopo senza lasciare traccia, prima di riemergere come oggetto di collezionismo soltanto negli anni Novanta. Gruppi come i Laser, e diversi altri se ne possono citare, documentano un periodo forse irripetibile della musica rock italiana, divisa tra i picchi artistici che sappiamo e produzioni, invece, di livello assai inferiore. |
"Vita sul pianeta" |
||||||||
| Dei Latte e Miele, band formata a Genova nel 1971, è difficile dare un giudizio univoco. I tre musicisti genovesi (tastiere, basso/chitarre, batteria) sono tutti giovanissimi, a cominciare dal batterista Alfio Vitanza, all'epoca sedicenne, e debuttano con un album molto ambizioso fin dal titolo, che si richiama in un colpo solo a J.S. Bach e ai Vangeli: "Passio Secundum Mattheum"(1972). Il disco, pubblicato dalla Polydor, viene presentato dal vivo al Teatro Pontificio di Roma con l'apporto del Coro dell'Opera, e suscita molto interesse anche perché si ricollega al filone mistico-religioso che in Italia ebbe un certo seguito già all'epoca delle Messe Beat. Musicalmente, però, i risultati sono molto alterni. Fin dalla suggestiva "Introduzione", interpolando con disinvoltura citazioni dei passi di Matteo e fughe d'organo ("Getzemani"), con enfatico dispiegamento di cori lirici ("Il Calvario"), tra le tastiere sinfoniche di Oliviero Lavagnina e gli spunti chitarristici di Marcello Della Casa, il gruppo regala comunque momenti di un certo fascino, ma eccede spesso nella ricerca di effetti discutibili: lasciano interdetti soprattutto i pezzi cantati e recitati, non sempre sposati a dovere con la parte musicale ("I testimoni"). Il secondo album è invece il 'concept' "Papillon" (1973): in questo caso la musica è più vicina ad altre formazioni triangolari della scena britannica, E.L.P. in testa. La trama della lunga suite omonima, divisa in sette "quadri" più l'overture, ruota attorno al surreale rapporto tra il burattino Papillon e una bambina: nonostante un'ispirazione meglio dosata rispetto all'esordio, non tutto funziona. Il terzo quadro, "L'incontro", è un brano molto ben costruito, ma l'insieme suona ripetitivo, specie nelle parti cantate, e il trio non sa personalizzare una formula sonora ormai inflazionata. Va meglio con la tripartita "Patetica": il gruppo rilegge l'omonima sonata di Beethoven nella prima parte, insieme però a citazioni di altri compositori (da Bach a Tchaikovsky), mentre la seconda è ispirata alla "Primavera" di Vivaldi, in un brioso accumulo di spunti, fino al jazz, e la terza infine è cantata coralmente. Dopo una pausa, e due singoli realizzati nel 1974, il solo batterista Alfio Vitanza realizza con una nuova formazione "Aquile e scoiattoli" nel 1976: è un album dall'impostazione variegata, che include tracce più melodiche come la title track, con liriche interessanti, ma anche l'ennesima rilettura classica di Beethoven ("Opera 21") e una lunga e raffinata suite di taglio sinfonico come "Pavana", sicuramente di buon livello. Nel 1992 esce un "Live" datato 1974 e nel 1996 "Vampyrs", sempre con vecchio materiale dei tardi '70. Riformata nel 2008, la band genovese ha realizzato prima un album come "Live Tasting", e quindi nel 2009 è uscito "Marco Polo-Sogni e viaggi". Altre informazioni qui . |
"Passio Secundum Mattheum" |
||||||||
| Questo gruppo oggi dimenticato si forma a Berlino nel 1971, e lascia alle cronache del rock un solo album. Realizzato nel 1973 per la famosa etichetta Brain, e prodotto da Conny Plank, "Tears Are Goin' Home" rimane un disco controverso, ma piuttosto lontano dall'elite della scena tedesca dell'epoca. Il sestetto dimostra infatti una vena fin troppo eclettica, che abbraccia il krautrock più tipico come nella potente title-track di apertura, con la chitarra di Stefan Ostertag in primo piano insieme alla voce solista, ma anche suggestioni diverse non sempre focalizzate a dovere. "Would Be Better You Run", ad esempio, recupera un folk-rock di tipo americano, con un tema vocale quasi mantrico che scorre s'una base di chitarre acustiche e pianoforte, e la chitarra elettrica in appoggio: semplice, ma abbastanza efficace. Al contrario, "All My Love To You", pur nel medesimo solco del brano precedente, con chitarra acustica e organo sotto la voce ossessiva, suona piuttosto monocorde. Nel complesso, la sequenza dei Lava è improntata ad un certo tono dimesso e malinconico, con la prevalenza di atmosfere intimiste, e proprio in questa direzione vengono fuori le tracce più riuscite, seppure non sempre elaborate al meglio dal punto di vista dell'arrangiamento. Tra i momenti migliori c'è "Crimes of Love", sviluppata s'un arpeggio di chitarra e con il basso in evidenza, mentre il canto del batterista Archer Weaver interpreta efficacemente un sofferto blues in lentissimo crescendo d'intensità: sullo sfondo s'inseriscono poi organo, chitarra elettrica e il flauto di Jurgen Kraaz per un risultato d'insieme piuttosto suggestivo. Interessante anche "Mad Dog", un altro crescendo costruito stavolta sul pianoforte di Thomas Karrenbach, la chitarra psichedelica in appoggio e un buon lavoro percussivo di Waever, e quindi "Holy Fool", ancora un blues principalmente acustico con la voce solista a tratti supportata dal coro. La lunga "Piece of Peace", in coda, sviluppa i toni più ombrosi già emersi in una dimensione interamente strumentale, dove pianoforte, chitarre e percussioni aggiunte costruiscono un paesaggio evocativo e decisamente psichedelico, che richiama la musica più ipnotica dei Can. Alla fine, il solo disco pubblicato dai Lava non manca affatto di attrattive, ma l'approccio spontaneo e forse ancora acerbo del gruppo finisce spesso per nuocere all'effetto complessivo. Ristampe di TRC e Repertoire. |
"Tears Are Goin' Home" |
||||||||
| Originari di Tortona, in Piemonte, i Leoni ingrossano la folta schiera dei gruppi minori del pop-rock italiano firmando un unico album. Prima ancora però, nel 1970, il trio formato da Carlo Riccardi (tastiere/voce) con Giorgio Borgarelli (basso/chitarra) e il batterista Pierluigi Bertolini, realizza un 45 giri come "Ogni notte"/"Le bottiglie" per l'etichetta Ricordi. Solo l'anno seguente con la produzione di Enrico Riccardi, autore di musiche e testi, l'etichetta pubblica anche l'album "La foresta", una sequenza di dieci tracce timidamente concettuale: la foresta e il mondo animale sono qui un'allegoria della società umana. Come altri dischi italiani del periodo, si tratta di un tipico compromesso tra un pop leggero di buona fattura e qualche sonorità più audace e interessante, ma poco sviluppata, che in ogni caso resta lontana dal prog italiano maggiore. In generale, le tastiere di Carlo Riccardi hanno spesso il ruolo principale, come nell'apertura de "L'alba", episodio di buona atmosfera costruito sul pianoforte e su morbide linee di basso intorno alla voce solista, secondo uno schema che si ripete simile ne "Il rinoceronte", con vocalizzi femminili a supporto e l'organo in evidenza. Nel solco di questa formula melodica si iscrivono pure brani come "La rugiada" e quindi "Le giraffe", stavolta con un testo più satirico e un finale in crescendo su basso, piano a martello e percussioni. I momenti migliori del disco sono però da ricercarsi nella parte centrale. Prima "Jena Ridens", aperta ancora da basso e pianoforte in un clima più oscuro che poi si apre sull'organo e il canto solista, tra accelerazioni interne e un lungo assolo alla batteria di Bertolini; quindi "Lo stregone", dove il batterista si ripete con percussioni tribali congiunte in questo caso a declamazioni in lingua latina, sullo sfondo di un organo dal timbro drammatico. Le percussioni sono ancora protagoniste nel breve episodio strumentale di "Le scimmie", costruito sulla chitarra acustica e il basso pulsante di Borgarelli, stavolta affiancati anche dal flauto. A parte gli accenni sinfonici nel discreto epilogo de "Il tramonto", il resto scorre nei binari di un onesto pop melodico tipicamente italiano, come "L'incendio" ad esempio, senza troppi sussulti. Si segnala comunque "Sesso", col flauto dolce in uno schema ritmico di buona presa, un brano che Loredana Berté riprenderà anni dopo (col titolo "S.E.S.S.O.") nel suo primo album "Streaking", non a caso prodotto proprio da Enrico Riccardi. Dopo l'uscita dell'album, i Leoni continuano a suonare dal vivo per un paio d'anni, allargandosi a quartetto con l'arrivo del nuovo chitarrista Paolo Stella, prima di sciogliersi nel 1973. Ristampe in CD di BMG-Ricordi e in vinile a cura di Sony. |
"La foresta" |
||||||||
Nato nel 1953 a Ficarra (Messina), Franco Leprino è un artista legato alla musica elettronica che in Italia ha avuto pochi ma validi esponenti, da Roberto Cacciapaglia a Franco Battiato, solo per citare due nomi autorevoli. Dopo aver suonato in alcune formazioni rock locali, studia chitarra, contrappunto e composizione tra Messina, Milano e Siena, e nel 1977 realizza il suo unico album per l'etichetta Eleven di Aldo Pagani: "Integrati...Disintegrati" ( ). Il disco è in pratica una sola, lunghissima composizione nella quale l'artista suona tutte le chitarre, moog e sintetizzatori (V.C.S.3), oltre a vibrafono e scacciapensieri, accompagnato da pochi altri musicisti: l'organista Franco Lazzaro, il pianista Arnaldo Ciato e due fiatisti impegnati al flauto e all'oboe. Mancano totalmente le percussioni tradizionali, e la musica si sviluppa secondo un affascinante minimalismo, specie nella prima parte, che evoca suggestioni e stupori nella percezione del mondo, scivolando tra passaggi più melodici, o anche cameristici, ed altri più impervi e atonali comuni a molta avanguardia del Novecento. Partendo dall'idea che la musica, ormai fuori da ogni concezione mistica, debba essere sempre più calata nella realtà, Leprino sceglie allo scopo di mettere in musica anche le contraddizioni del nostro tempo: suoni concreti (rumori) e impressionismo, un pianto lacerante di neonato, sonorità morbide ma anche spigolose, convivono in un impasto fatto di pause rarefatte e riprese dei singoli temi che alla fine sprigiona buone vibrazioni, catturando l'ascoltatore nelle sue spirali. A pacati arpeggi di chitarra acustica con il flauto in appoggio, oppure delicati inserti di pianoforte e oboe, si alternano così derive elettroniche e sintetiche, tra echi e sfocature sonore che rimandano a tratti ai cosmici tedeschi, ma senz'altro con maggiore varietà di accenti e una sensibilità melodica decisamente mediterranea. Al fondo della musica di Leprino, insomma, c'è sicuramente un colore, e un calore, che manca in altre esperienze di questo genere, e nonostante l'oggettiva difficoltà del primo impatto, la sequenza risulta stimolante e originale: appunto per questo, nonostante la totale assenza di suoni rock, il disco va inserito senz'altro nel filone della musica prog italiana più sperimentale. In seguito, Leprino si è segnalato soprattutto come musicologo e docente di musica in varie Università, oltre che regista molto apprezzato nel campo dell'audiovisivo. A parte le ristampe di Vinyl Magic (CD) e della spagnola Wah Wah (vinile), l'etichetta Giallo Records ha pubblicato nel 2009 il CD "1977 - 1987 Original Versions", che include l'album del 1977 insieme a undici tracce inedite degli anni Ottanta, ugualmente interessanti. Le molteplici attività di Franco Leprino sono documentate nel sito www.gransole.net. ). Il disco è in pratica una sola, lunghissima composizione nella quale l'artista suona tutte le chitarre, moog e sintetizzatori (V.C.S.3), oltre a vibrafono e scacciapensieri, accompagnato da pochi altri musicisti: l'organista Franco Lazzaro, il pianista Arnaldo Ciato e due fiatisti impegnati al flauto e all'oboe. Mancano totalmente le percussioni tradizionali, e la musica si sviluppa secondo un affascinante minimalismo, specie nella prima parte, che evoca suggestioni e stupori nella percezione del mondo, scivolando tra passaggi più melodici, o anche cameristici, ed altri più impervi e atonali comuni a molta avanguardia del Novecento. Partendo dall'idea che la musica, ormai fuori da ogni concezione mistica, debba essere sempre più calata nella realtà, Leprino sceglie allo scopo di mettere in musica anche le contraddizioni del nostro tempo: suoni concreti (rumori) e impressionismo, un pianto lacerante di neonato, sonorità morbide ma anche spigolose, convivono in un impasto fatto di pause rarefatte e riprese dei singoli temi che alla fine sprigiona buone vibrazioni, catturando l'ascoltatore nelle sue spirali. A pacati arpeggi di chitarra acustica con il flauto in appoggio, oppure delicati inserti di pianoforte e oboe, si alternano così derive elettroniche e sintetiche, tra echi e sfocature sonore che rimandano a tratti ai cosmici tedeschi, ma senz'altro con maggiore varietà di accenti e una sensibilità melodica decisamente mediterranea. Al fondo della musica di Leprino, insomma, c'è sicuramente un colore, e un calore, che manca in altre esperienze di questo genere, e nonostante l'oggettiva difficoltà del primo impatto, la sequenza risulta stimolante e originale: appunto per questo, nonostante la totale assenza di suoni rock, il disco va inserito senz'altro nel filone della musica prog italiana più sperimentale. In seguito, Leprino si è segnalato soprattutto come musicologo e docente di musica in varie Università, oltre che regista molto apprezzato nel campo dell'audiovisivo. A parte le ristampe di Vinyl Magic (CD) e della spagnola Wah Wah (vinile), l'etichetta Giallo Records ha pubblicato nel 2009 il CD "1977 - 1987 Original Versions", che include l'album del 1977 insieme a undici tracce inedite degli anni Ottanta, ugualmente interessanti. Le molteplici attività di Franco Leprino sono documentate nel sito www.gransole.net.
|
"Integrati...Disintegrati"
|
||||||||
Percorso piuttosto insolito quello dei Libra, una formazione romana nata nel 1973 sulle ceneri dei Logan Dwight: ne facevano parte Federico d'Andrea e Franco Ventura, il quale però abbandona abbastanza presto il nuovo progetto. Dopo aver partecipato al musical "Jacopone" nel 1973, la band si schiera a quintetto l'anno seguente con l'ingresso del bassista Dino Cappa, e viene messa sotto contratto dalla Ricordi: "Musica e parole" ( ) è il titolo del primo album pubblicato nel 1975, con la produzione di Claudio Fabi e Danny Besquet. E' una proposta molto personale diluita in sei episodi suonati con notevole padronanza tecnica: è un jazz-rock basato sulle chitarre, spesso melodico e con una patina "funky" molto pronunciata, che differenzia i Libra dal prog italiano dell'epoca, principalmente dedito al modello sinfonico di scuola inglese. L'apertura di "Nato oggi" mostra subito la brillante caratura del quintetto, con la voce solista di D'Andrea in evidenza nella prima parte, seguita poi da un vorticoso jazz-rock nel quale spiccano il basso pirotecnico di Cappa e la chitarra solista di Nicola Di Staso. Un sound ancora più "americano" affiora in "Beyond the Fence", cantato in inglese tra vivaci effetti live, con trascinanti passaggi strumentali dominati dalle voci, anche corali, il piano elettrico di Sandro Centofanti (ex Buon Vecchio Charlie) e le chitarre. Più avvolgente la sequenza "Il tempo è un buon amico / Forse è una furia", con cambi di tempo e belle parti vocali, mentre la title track è una lunga composizione per pianoforte e voce che sale d'intensità alla distanza. Insolito e suggestivo anche il lungo epilogo di "Inquinamento", con una lunga introduzione atmosferica e un testo in dialetto romanesco sui disastri ambientali, recitato sullo sfondo dell'organo e con la chitarra ancora sugli scudi. Registrato anche in edizione inglese, il disco piace molto agli americani, al punto che Danny Besquet spunta per i Libra un contratto con la prestigiosa etichetta Motown che prevede addirittura la realizzazione di dieci album. Così, dopo un tour italiano con il Banco, il gruppo recluta il nuovo batterista Walter Martino e nell'autunno del 1975 vola in USA per suonare di spalla ad artisti di primissimo piano quali Frank Zappa e Chicago. Il secondo album, pubblicato solo in America dalla Motown, è "Winter Day's Nightmare" (1976), ma nonostante le buone premesse non riscuote il successo sperato e al ritorno in Italia la band comincia a sfaldarsi. In una nuova versione, con Maurizio Guarini (Goblin) e Carlo Pennisi (ex Flea) che rilevano Di Staso e D'Andrea, il gruppo si riunisce infine per registrare "Schock" (1977), colonna sonora dell'omonimo film di Mario Bava: un lavoro a tinte forti, ricco di intriganti passaggi strumentali, che rimane però l'ultimo atto ufficiale di questa valida e atipica formazione italiana. Ristampe in CD a cura di Sony-BMG e Cinevox. ) è il titolo del primo album pubblicato nel 1975, con la produzione di Claudio Fabi e Danny Besquet. E' una proposta molto personale diluita in sei episodi suonati con notevole padronanza tecnica: è un jazz-rock basato sulle chitarre, spesso melodico e con una patina "funky" molto pronunciata, che differenzia i Libra dal prog italiano dell'epoca, principalmente dedito al modello sinfonico di scuola inglese. L'apertura di "Nato oggi" mostra subito la brillante caratura del quintetto, con la voce solista di D'Andrea in evidenza nella prima parte, seguita poi da un vorticoso jazz-rock nel quale spiccano il basso pirotecnico di Cappa e la chitarra solista di Nicola Di Staso. Un sound ancora più "americano" affiora in "Beyond the Fence", cantato in inglese tra vivaci effetti live, con trascinanti passaggi strumentali dominati dalle voci, anche corali, il piano elettrico di Sandro Centofanti (ex Buon Vecchio Charlie) e le chitarre. Più avvolgente la sequenza "Il tempo è un buon amico / Forse è una furia", con cambi di tempo e belle parti vocali, mentre la title track è una lunga composizione per pianoforte e voce che sale d'intensità alla distanza. Insolito e suggestivo anche il lungo epilogo di "Inquinamento", con una lunga introduzione atmosferica e un testo in dialetto romanesco sui disastri ambientali, recitato sullo sfondo dell'organo e con la chitarra ancora sugli scudi. Registrato anche in edizione inglese, il disco piace molto agli americani, al punto che Danny Besquet spunta per i Libra un contratto con la prestigiosa etichetta Motown che prevede addirittura la realizzazione di dieci album. Così, dopo un tour italiano con il Banco, il gruppo recluta il nuovo batterista Walter Martino e nell'autunno del 1975 vola in USA per suonare di spalla ad artisti di primissimo piano quali Frank Zappa e Chicago. Il secondo album, pubblicato solo in America dalla Motown, è "Winter Day's Nightmare" (1976), ma nonostante le buone premesse non riscuote il successo sperato e al ritorno in Italia la band comincia a sfaldarsi. In una nuova versione, con Maurizio Guarini (Goblin) e Carlo Pennisi (ex Flea) che rilevano Di Staso e D'Andrea, il gruppo si riunisce infine per registrare "Schock" (1977), colonna sonora dell'omonimo film di Mario Bava: un lavoro a tinte forti, ricco di intriganti passaggi strumentali, che rimane però l'ultimo atto ufficiale di questa valida e atipica formazione italiana. Ristampe in CD a cura di Sony-BMG e Cinevox. |
"Musica e parole" |
||||||||
| (SWE) - Una band svedese dalla stringata discografia, capace però di lasciare una buona impressione ancora oggi. Nati nei dintorni di Stoccolma nel 1970 come trio (tastiere/chitarra, chitarre/basso e batteria), i Life realizzano un primo singolo nel settembre dello stesso anno e subito a ruota pubblicano quindi il loro album omonimo in lingua svedese, poi riedito in inglese nel 1971. Quest'ultima versione è quella tuttora in circolazione, e guadagna al trio molti elogi in patria. Effettivamente, il disco dei Life ha mantenuto una certa freschezza esecutiva, anche se non manca di qualche difetto, e in alcuni momenti resta ancora legato al decennio precedente. Dalla fertile vena del tastierista Anders Nordh e del bassista/chitarrista Paul Sundlin, infatti, escono comunque quattordici tracce di limpido rock, spesso felicemente melodico, corroborato dalle vibranti voci dei due. Si passa così dal rock tagliente di "Nobody Was There to Love Me" e quello francamente elettrico di "Sailing in the Sunshine", oltre alla meno riuscita "Living is Loving", alla grazia più classicheggiante di "She Walks Across the Room", con tanto di pianoforte a sottolineare il crescendo emotivo, fino a "One of Us", che mescola le voci in sordina a squarci di rock psichedelico, con un pianoforte molto estroso. Tuttavia il gioiello del disco è "Once Upon a Time": l'apertura romantica e la voce solista creano un seducente effetto evocativo, garantito dall'arrangiamento orchestrale, che culmina poi in un finale da brividi. I brani più lunghi della sequenza sono poi inframmezzati dai tre brevi episodi di "Quo vadis", dove l'anima del trio svedese sembra esprimere velleità più sperimentali, in bilico tra musica colta e provocazione psichedelica, anche se non sviluppata come potrebbe. Dopo una lunga tournee per la versione teatrale del famoso musical "Hair", il gruppo si sciolse nel '72 senza possibilità di sviluppare e focalizzare meglio le proprie qualità. Resta comunque un disco godibile, non sempre impeccabile e dai forti contrasti, ma alla fine sempre gradevole e non di rado sorprendente. Nordh e Sundlin restano i più attivi in altre rock-band svedesi di poca fortuna, come Figaro e Resan. La ristampa digitale Mellotronen (1997) include tre bonus-tracks, ma esiste anche l'edizione in vinile a cura di Golden Pavilion. |
"Life" |
||||||||
| (UK) - Tra i molti gruppi degli anni Settanta (e oltre) operanti con questa sigla, i Life inglesi nascono nel 1970 come quartetto e si sciolgono dopo il loro unico disco realizzato nel 1974 per la Polydor: "Life After Death". I due membri più noti della band, che nasce sulle ceneri dei Moonstone, sono il valido tastierista Ian Gibbons, con un passato da bambino-prodigio, e il polistrumentista Roger Cotton, in seguito collaboratore di svariati artisti. La proposta dei Life, distillata in dieci tracce, è una singolare mistura di hard rock melodico e prog, quasi sempre suonato come si deve, anche se lontano dai picchi che altre band dell'epoca hanno saputo esprimere. Poiché ben tre membri su quattro ricoprono le parti cantate, le buone armonie vocali colorano la musica di vibrazioni positive tra rock e pop, ma sempre a un livello dignitoso: ad esempio l'attacco di "Riding Around", dove il tema cantabile è spezzato dal fraseggio dell'organo di Gibbons. "I Don't Want To", ancora più frizzante e dinamica, ribadisce lo schema alternando sapidi soli chitarristici di Cotton con le voci corali e parti organistiche in una sorta di flash-rock che a tratti può ricordare gli Yes. Una traccia come "Sleepless Night" è invece più vicina a un certo hard rock, con frequenti breaks chitarristici e un vivace lavoro della batteria di Paul Thorpe, ma l'organo sempre in cattedra, e lo stesso può dirsi per brani come "Woman", ancora s'un ritmo battente e le armonie corali in evidenza: da notare qui la buona tenuta della batteria e del basso (Paul Thorpe). Il sound del quartetto ha pure qualcosa del rock americano, anche per la ricerca del tema portante di facile presa, e nella scorrevolezza di scrittura: lo confermano brani come "Highway", punteggiato dalla chitarra solista e dal piano di Cotton in uno schema compatto e tagliente, infarcito di cori incisivi, che ricorda davvero certo Southern Rock, anche se la coda è ancora dominata dall'organo Hammond. Sapori prog più intriganti caratterizzano invece "Everybody's Queuing to Be Last", abilmente sviluppata tra pieni e vuoti in tumultuosa tensione tra organo, piano e sezione ritmica che lascia il segno e forse è il picco vero dell'album, mentre la conclusiva "The Plank/Devil on the River", articolata sul pianoforte di Cotton, è una tiratissima sgroppata di atmosfera vagamente gotica, in linea con la cover orrorifica e il titolo stesso del disco. Alla fine, se "Life After Death" non è un capolavoro, rimane un apprezzabile esempio di prog-rock non troppo complesso ma ben suonato, e valorizzato soprattutto dalla brillante vena tastieristica di Gibbons, il quale in seguito farà parte dei rinomati Kinks per un decennio esatto (1979-'89). Ristampato in vinile e CD. |
"Life After Death"
|
||||||||
| Questo gruppo olandese prende corpo a Gouda e con il nome di Light Formation si esibisce dal vivo già alla fine degli anni Sessanta. Solo nel 1972 la band trova un contratto discografico con l'etichetta Barclay Records e, accorciata la sigla per l'occasione, realizza lo stesso anno quello che rimarrà il suo unico album: "The Story of Moses". Come s'intuisce dal titolo, si tratta di un classico concept di argomento biblico: in sei episodi è così narrata la storia di Mosè, che guidò il popolo ebraico fuori dall'Egitto verso la terra promessa. Il gruppo è un quintetto nel quale il ruolo dominante è svolto dalle ricche tastiere di Adri Vergeer, autore del materiale, che indirizza perciò la musica verso una dimensione sinfonica indubbiamente adeguata al contesto. L'attacco di "The Water" è molto eloquente: toni solenni ed evocativi, con il mellotron e l'organo in primo piano, con morbidi arpeggi di chitarra in appoggio, e placide parti vocali dello stesso Vergeer, mentre la chitarra elettrica dell'ospite Hans Hollestelle incide solo nella seconda parte. Non mancano in realtà nella sequenza momenti strumentali più vivaci, a cominciare dalla lunga "The Blackberry Bushes", dove la chitarra solista e soprattutto le percussioni creano un'atmosfera più mossa, quasi sulle tracce del "latin rock" di Santana, prima che il tastierista si riprenda la scena in lunghi fraseggi all'organo, con apprezzabili inserti del flauto di Hans de Bruin. Altrove il prog dei Light sfodera tonalità barocche, come in "White Turns into Black", tra fughe organistiche sull'esempio di Bach e il buon apporto di basso e flauto. Interessante anche un episodio come "The Nuisances", dove il vivace tema delle tastiere si sposa con gradevoli parti vocali, attraverso movenze barocche ben congegnate che includono un breve inserto del chitarrista. Il brano meno convincente è invece "The Desert": c'è una certa enfasi predicatoria, con recitativi dall'effetto un po' datato, che inficia il risultato finale del pezzo. Nel complesso "The Story of Moses" ha dei buoni momenti, ma non è un disco fondamentale del rock anni Settanta, nonostante le ottime capacità di Vergeer, che dimostra talento e una certa versatilità di scrittura. Per questo motivo il solo album dei Light può interessare soprattutto gli appassionati del prog basato sulle tastiere. Ristampe in CD di Estrella Rockera. |
"The Story of Moses" |
||||||||
Gruppo tedesco originario di Emmerich am Rhein (Westfalia), formato nel 1974, che ha realizzato un solo album nella sua breve esistenza. Del quintetto che nel 1976 realizza "Feeling" ( ) per l'etichetta Trefiton, si conoscono soltanto i nomi di battesimo, ma nonostante le scarse notizie il disco è davvero di buon livello, un esempio decisamente personale di "space rock" dalle tinte psichedeliche. Nelle cinque tracce, tutte ben suonate, un ruolo fondamentale hanno le due chitarre di Ulli e Joe, che rendono sempre dinamica e brillante la ricetta sonora, mentre il synth di Olli opera soprattutto in appoggio. Sin dall'attacco di "Sword in the Sky", il rock dei Lightshine allinea tonalità evocative, con tanto di flauto in bella evidenza nella seconda parte, a repentini cambi di tempo e parti vocali in inglese spesso sopra le righe. Il culmine di questo indirizzo stilistico, variegato e imprevedibile, è probabilmente nella lunga "King and Queen", dove il testo dialogico mette in scena un re sanguinario e una regina inerme: toni prima lirici e poi grotteschi inseriti all'interno d'un pezzo musicalmente molto bello, con una morbida chitarra "floydiana" che dipinge un'atmosfera sognante e raffinata. In "Lory" trionfa un rock costruito sul basso, con chitarre lanciate poi in pregevoli tirate solistiche, mentre il canto incide ancora piuttosto graffiante. Tra i momenti più suggestivi va segnalata "Nightmare", con la sua dimensione onirica e psichedelica che cresce sulle chitarre e il synth, e parti vocali stavolta più pacate fino alla cesura ritmica a metà del brano. Stessi umori psichedelici nella finale title-track, con delicati arpeggi chitarristici ed effetti percussivi di sfondo: assorte armonie vocali s'intrecciano mentre il pezzo cresce d'intensità sulle chitarre e la batteria, con effetti di synth e voci concitate quasi da film horror. Un epilogo degno dell'album, sempre in bilico tra rilassanti atmosfere e soprassalti inopinati, con le bizzarre parti cantate in primo piano. I Lightshine si sciolgono nel 1977 senza poter dare un seguito al loro esordio, ma "Feeling" resta un disco indubbiamente valido: forse non sempre compattato a dovere e con qualche lungaggine, e tuttavia una spanna al di sopra di tanto Krautrock in quanto a personalità e intuizioni. Ristampe digitali a cura di Garden Of Delights. ) per l'etichetta Trefiton, si conoscono soltanto i nomi di battesimo, ma nonostante le scarse notizie il disco è davvero di buon livello, un esempio decisamente personale di "space rock" dalle tinte psichedeliche. Nelle cinque tracce, tutte ben suonate, un ruolo fondamentale hanno le due chitarre di Ulli e Joe, che rendono sempre dinamica e brillante la ricetta sonora, mentre il synth di Olli opera soprattutto in appoggio. Sin dall'attacco di "Sword in the Sky", il rock dei Lightshine allinea tonalità evocative, con tanto di flauto in bella evidenza nella seconda parte, a repentini cambi di tempo e parti vocali in inglese spesso sopra le righe. Il culmine di questo indirizzo stilistico, variegato e imprevedibile, è probabilmente nella lunga "King and Queen", dove il testo dialogico mette in scena un re sanguinario e una regina inerme: toni prima lirici e poi grotteschi inseriti all'interno d'un pezzo musicalmente molto bello, con una morbida chitarra "floydiana" che dipinge un'atmosfera sognante e raffinata. In "Lory" trionfa un rock costruito sul basso, con chitarre lanciate poi in pregevoli tirate solistiche, mentre il canto incide ancora piuttosto graffiante. Tra i momenti più suggestivi va segnalata "Nightmare", con la sua dimensione onirica e psichedelica che cresce sulle chitarre e il synth, e parti vocali stavolta più pacate fino alla cesura ritmica a metà del brano. Stessi umori psichedelici nella finale title-track, con delicati arpeggi chitarristici ed effetti percussivi di sfondo: assorte armonie vocali s'intrecciano mentre il pezzo cresce d'intensità sulle chitarre e la batteria, con effetti di synth e voci concitate quasi da film horror. Un epilogo degno dell'album, sempre in bilico tra rilassanti atmosfere e soprassalti inopinati, con le bizzarre parti cantate in primo piano. I Lightshine si sciolgono nel 1977 senza poter dare un seguito al loro esordio, ma "Feeling" resta un disco indubbiamente valido: forse non sempre compattato a dovere e con qualche lungaggine, e tuttavia una spanna al di sopra di tanto Krautrock in quanto a personalità e intuizioni. Ristampe digitali a cura di Garden Of Delights.
|
"Feeling" |
||||||||
Ennesima meteora della prolifica scena tedesca dei primi Settanta, Lily è una formazione originaria di Francoforte, dove nasce in realtà con il nome di Monsun intorno al 1969, sotto la guida di Manfred-Josef Schmid (chitarra) e Wilfried Kirchmeier (basso). L'idea di suonare canzoni con testi politici in lingua madre viene presto abbandonata, ma dal 1970 il gruppo comincia a esibirsi intensamente dal vivo e si costruisce una solida fama nel circuito locale, finché l'arrivo del secondo chitarrista Klaus Lehmann completa l'organico e il quintetto spunta un contratto con la Bacillus. Scelta per l'occasione la nuova sigla Lily, il gruppo realizza quindi il suo unico album intitolato "V.C.U.(we see you)" ( ), pubblicato nella primavera del 1973. Fin dal vibrante attacco di "In Those Times", tra i picchi della sequenza, il gruppo mostra grande energia e originalità: in una successione imprevedibile di pieni e vuoti, con il canto in inglese del bassista Wilfried Kirchmeier, si segnalano la chitarra solista di Schmid e anche il sax di Hans-Werner Steinberg, ben sostenuti dalla possente sezione ritmica. E' un vivace rock psichedelico, arricchito da sapori jazz e sempre aperto alle trovate dei singoli. Il gioco delle due chitarre, in assenza delle tastiere, è il perno vero della musica, ma il sax è ugualmente protagonista, e lo si vede bene in "Which is This", dove duetta al meglio con la chitarra. In "Dr. Martin", con il canto solista inizialmente protagonista, sono ancora le chitarre e una ruggente sezione ritmica a dividersi la scena nella seconda parte. Anche se la resa finale suona a volte un po' ruvida, come nelle parti vocali, la buona vena del quintetto riesce comunque a catturare l'attenzione. Intrigante ad esempio "Pinky Pigs", con il basso abile a tenere insieme la linea ondivaga e jazzata del brano insieme alle percussioni di Manfred Schlagmüller, mentre il sax e la chitarra esaltano un'atmosfera liquida e quasi esotica di grande effetto. Linee di chitarra ariose dominano "I'm Lying on My Belly", col sax soprano che si avvita in lunghe derive preludio a una bella accelerazione nel finale, mentre l'epilogo della lunga "Eyes Look From the Mount of Flash", vede ancora scatenarsi il batterista in combinazione con il basso, prima che irrompa la chitarra abrasiva di Schmid: è una traccia pulsante, ricca di breaks e inserti a sorpresa del sax, con spazi d'improvvisazione che lasciano il segno fino al gong finale. E' il degno sigillo per un album che dimostra il genuino talento di questa band tedesca, ma poco dopo Manfred Schmid lascia il gruppo e manifesta problemi mentali, finché muore in circostanze misteriose. I Lily provano a continuare tra vari avvicendamenti, ma i nuovi pezzi proposti non suscitano alcun interesse discografico, e dopo un'ultimo concerto a Bayreuth nel 1976 il gruppo si disperde. Ristampe in CD con bonus-tracks (Garden of Delights) e in vinile (Long Hair). ), pubblicato nella primavera del 1973. Fin dal vibrante attacco di "In Those Times", tra i picchi della sequenza, il gruppo mostra grande energia e originalità: in una successione imprevedibile di pieni e vuoti, con il canto in inglese del bassista Wilfried Kirchmeier, si segnalano la chitarra solista di Schmid e anche il sax di Hans-Werner Steinberg, ben sostenuti dalla possente sezione ritmica. E' un vivace rock psichedelico, arricchito da sapori jazz e sempre aperto alle trovate dei singoli. Il gioco delle due chitarre, in assenza delle tastiere, è il perno vero della musica, ma il sax è ugualmente protagonista, e lo si vede bene in "Which is This", dove duetta al meglio con la chitarra. In "Dr. Martin", con il canto solista inizialmente protagonista, sono ancora le chitarre e una ruggente sezione ritmica a dividersi la scena nella seconda parte. Anche se la resa finale suona a volte un po' ruvida, come nelle parti vocali, la buona vena del quintetto riesce comunque a catturare l'attenzione. Intrigante ad esempio "Pinky Pigs", con il basso abile a tenere insieme la linea ondivaga e jazzata del brano insieme alle percussioni di Manfred Schlagmüller, mentre il sax e la chitarra esaltano un'atmosfera liquida e quasi esotica di grande effetto. Linee di chitarra ariose dominano "I'm Lying on My Belly", col sax soprano che si avvita in lunghe derive preludio a una bella accelerazione nel finale, mentre l'epilogo della lunga "Eyes Look From the Mount of Flash", vede ancora scatenarsi il batterista in combinazione con il basso, prima che irrompa la chitarra abrasiva di Schmid: è una traccia pulsante, ricca di breaks e inserti a sorpresa del sax, con spazi d'improvvisazione che lasciano il segno fino al gong finale. E' il degno sigillo per un album che dimostra il genuino talento di questa band tedesca, ma poco dopo Manfred Schmid lascia il gruppo e manifesta problemi mentali, finché muore in circostanze misteriose. I Lily provano a continuare tra vari avvicendamenti, ma i nuovi pezzi proposti non suscitano alcun interesse discografico, e dopo un'ultimo concerto a Bayreuth nel 1976 il gruppo si disperde. Ristampe in CD con bonus-tracks (Garden of Delights) e in vinile (Long Hair).
|
"V.C.U.(we see you)"
|
||||||||
Uno dei molti gruppi italiani dimenticati, i Living Life si formano a Torino su iniziativa del batterista Roberto Betti, a suo tempo con i Circus 2000 del primo disco. Lasciata la band, Betti suona jazz e quindi vive un anno in Afghanistan. Rientrato in Italia, mette in piedi un sestetto che include anche il chitarrista Marcello Quartarone (altro reduce dai Circus 2000) e il fiatista Walter Negri, e realizza nel 1975 "Let: From Experience to Experience", album che inaugura la piccola label Shirak, gestita dallo stesso Betti. I sei brani del disco, interamente strumentale a parte "Let", cantata in inglese, propongono una ricetta fusion che mescola jazz, un po' di rock e qualche sapore etnico. Il flauto delicato di Negri guida l'apertura di "Studio in La minore", insieme al pianoforte di Piercarlo Bettini: un episodio indubbiamente elegante, ma frammentario. E' un po' la cifra dell'intera sequenza, anche se alcuni episodi mostrano qualità di prim'ordine: ad esempio "Straight Down", con la chitarra solista di Quartarone in bella evidenza con i picchi del sax, o la più tesa e vibrante "From Marocco", con le percussioni protagoniste insieme a fiati, chitarra e pianoforte. Tra alterne vicende, passano ben sei anni prima che il gruppo si riaffacci sul mercato discografico. Solo nel 1981 esce infatti "Mysterious Dream" ( ), inciso da una formazione molto diversa: con Betti e il bassista Savarro, suonano quattro nuovi elementi, mentre Bettini è presente solo in qualità di ospite. Rispetto al precedente, è un disco più compatto e rifinito, con un utilizzo organico delle tastiere, specie del synth di Aldo Valente. Lo si nota nell'apertura ad effetto di "Welcome People" e soprattutto nella splendida title-track, che scorre tra sonorità esotiche ben dosate e intriganti parti vocali, ancora in inglese, inserite a dovere nel corposo tessuto strumentale, con il flauto, l'oboe e la chitarra solista di Daniele Pintaldi in evidenza. Molto elegante è "Oldeurope", episodio costruito sull'oboe di Gianni Cinti e sul pianoforte, che cresce alla distanza sull' organo e la batteria. Il jazz fa capolino soprattutto nella coda di "Sliding Through the Clouds of Cusco", con flauto e piano che guidano le danze sul sofisticato tappeto ritmico. L'altro episodio cantato è "Living With the Music", che si apprezza ancora per il ruolo centrale dell'oboe in un'atmosfera sospesa, sostenuta ad arte dal lavoro congiunto di basso e batteria. Un bel disco, che rimane il miglior contributo dei Living Life alla scena prog italiana, seppure giunto fuori tempo massimo. Ristampe Mellow Records. ), inciso da una formazione molto diversa: con Betti e il bassista Savarro, suonano quattro nuovi elementi, mentre Bettini è presente solo in qualità di ospite. Rispetto al precedente, è un disco più compatto e rifinito, con un utilizzo organico delle tastiere, specie del synth di Aldo Valente. Lo si nota nell'apertura ad effetto di "Welcome People" e soprattutto nella splendida title-track, che scorre tra sonorità esotiche ben dosate e intriganti parti vocali, ancora in inglese, inserite a dovere nel corposo tessuto strumentale, con il flauto, l'oboe e la chitarra solista di Daniele Pintaldi in evidenza. Molto elegante è "Oldeurope", episodio costruito sull'oboe di Gianni Cinti e sul pianoforte, che cresce alla distanza sull' organo e la batteria. Il jazz fa capolino soprattutto nella coda di "Sliding Through the Clouds of Cusco", con flauto e piano che guidano le danze sul sofisticato tappeto ritmico. L'altro episodio cantato è "Living With the Music", che si apprezza ancora per il ruolo centrale dell'oboe in un'atmosfera sospesa, sostenuta ad arte dal lavoro congiunto di basso e batteria. Un bel disco, che rimane il miglior contributo dei Living Life alla scena prog italiana, seppure giunto fuori tempo massimo. Ristampe Mellow Records.
|
"Mysterious Dream" |
||||||||
Originale esperienza della scena italiana dei Settanta, Living Music non è tanto un gruppo quanto una sorta di collettivo aperto con base a Roma che ruota intorno a Umberto Santucci e Gianfranca Montedoro, una cantante jazz attiva fin dai primi anni Sessanta che collabora tra l'altro con i Brainticket, partecipando alla realizzazione di "Psychonaut" nel 1972. Più avanti, il sodalizio artistico col suo compagno Umberto Santucci si allarga fino a coinvolgere una piccola comunità di musicisti denominata Living Music, finché prende corpo l'idea di un album dedicato al noto poeta Beat americano Allen Ginsberg. Registrato alla fine del 1972 e pubblicato all'inizio del 1973 da BMG Ricordi, "To Allen Ginsberg" ( ) è un disco che ha pochi legami col rock progressivo in senso stretto, e piuttosto immerso nel clima della contro-cultura americana, con sonorità perlopiù acustiche in bilico tra acid-folk e jazz. Dei nove pezzi in scaletta, quattro sono appunto basati sui versi del poeta statunitense, cantati con buona verve da Gianfranca Montedoro, a cominciare dal celebre poema "Howl". La sua voce, molto duttile e incline ai toni più scuri, rende bene il pathos del testo, mentre la base musicale è un jazz scandito da un riff petulante di chitarra elettrica insieme alle percussioni di Mandrake, con inserti del sax di Enzo Scoppa e della tromba di Cicci Santucci. Un bel biglietto da visita. Morbido folk domina invece "Song", con la chitarra acustica che sostiene il canto solista affiancato dal coro e il flauto nel finale. Nella stessa scia scorre anche "Lysergic Acid", dove la bella voce femminile è cullata dalla chitarra, dal vibrafono di Nino De Rose e dal basso di Roberto Rosati, in un insieme finemente cesellato, mentre "Mandala" richiama l'India per la presenza del sitar di Costantino Albini, che torna anche nella chiusura di "Mantra". Umberto Santucci, impegnato soprattutto alle tastiere e a vari effetti speciali, firma intriganti episodi strumentali come "Off On", col suo pianoforte irregolare affiancato dalle percussioni e da suggestivi cori tribali, oppure "1968", col sax torturato di Scoppa s'uno sfondo percussivo carico di tensione. La sua arpa si ascolta inoltre in "Haiku", ancora dominato dalla voce di Gianfranca Montedoro e dal coro femminile. Insolito e lontano dai sapori tipicamente prog, l'unico album firmato dai Living Music è ancora oggi di godibile ascolto per la freschezza della proposta e per l'atmosfera sonora che cattura nelle sue spirali senza frontiere, tra Oriente e Occidente. Montedoro e gli altri partecipano anche a importanti raduni dell'epoca, ad esempio il Festival di Musica d'Avanguardia e Nuove Tendenze del Foro Italico (Roma 1972) e anche il "Be-In" di Napoli (1973). Chiusa comunque quell'esperienza, la cantante incide un album solista come "Donna Circo" nel 1974, suonato con alcuni musicisti dei Murple su testi di Paola Pallottino, in pratica però mai distribuito per il fallimento dell'etichetta BASF. In seguito ha continuato a cantare jazz, collaborando con diversi gruppi e artisti. La ristampa in CD è a cura di BMG-Ricordi, quella in vinile dell'australiana Roundtable. ) è un disco che ha pochi legami col rock progressivo in senso stretto, e piuttosto immerso nel clima della contro-cultura americana, con sonorità perlopiù acustiche in bilico tra acid-folk e jazz. Dei nove pezzi in scaletta, quattro sono appunto basati sui versi del poeta statunitense, cantati con buona verve da Gianfranca Montedoro, a cominciare dal celebre poema "Howl". La sua voce, molto duttile e incline ai toni più scuri, rende bene il pathos del testo, mentre la base musicale è un jazz scandito da un riff petulante di chitarra elettrica insieme alle percussioni di Mandrake, con inserti del sax di Enzo Scoppa e della tromba di Cicci Santucci. Un bel biglietto da visita. Morbido folk domina invece "Song", con la chitarra acustica che sostiene il canto solista affiancato dal coro e il flauto nel finale. Nella stessa scia scorre anche "Lysergic Acid", dove la bella voce femminile è cullata dalla chitarra, dal vibrafono di Nino De Rose e dal basso di Roberto Rosati, in un insieme finemente cesellato, mentre "Mandala" richiama l'India per la presenza del sitar di Costantino Albini, che torna anche nella chiusura di "Mantra". Umberto Santucci, impegnato soprattutto alle tastiere e a vari effetti speciali, firma intriganti episodi strumentali come "Off On", col suo pianoforte irregolare affiancato dalle percussioni e da suggestivi cori tribali, oppure "1968", col sax torturato di Scoppa s'uno sfondo percussivo carico di tensione. La sua arpa si ascolta inoltre in "Haiku", ancora dominato dalla voce di Gianfranca Montedoro e dal coro femminile. Insolito e lontano dai sapori tipicamente prog, l'unico album firmato dai Living Music è ancora oggi di godibile ascolto per la freschezza della proposta e per l'atmosfera sonora che cattura nelle sue spirali senza frontiere, tra Oriente e Occidente. Montedoro e gli altri partecipano anche a importanti raduni dell'epoca, ad esempio il Festival di Musica d'Avanguardia e Nuove Tendenze del Foro Italico (Roma 1972) e anche il "Be-In" di Napoli (1973). Chiusa comunque quell'esperienza, la cantante incide un album solista come "Donna Circo" nel 1974, suonato con alcuni musicisti dei Murple su testi di Paola Pallottino, in pratica però mai distribuito per il fallimento dell'etichetta BASF. In seguito ha continuato a cantare jazz, collaborando con diversi gruppi e artisti. La ristampa in CD è a cura di BMG-Ricordi, quella in vinile dell'australiana Roundtable.
|
"To Allen Ginsberg" |
||||||||
Un gruppo di Amburgo formato nel 1970, che realizza prima un disco col nome di Asterix, e quindi con la nuova sigla firma una nutrita discografia fino al 1994. Guidati dal potente cantante inglese John Lawton, i Lucifer's Friend realizzano un album di debutto omonimo (gennaio 1971) che suscita unanimi consensi: otto tracce abrasive che richiamano da vicino i maestri dell'hard rock inglese. Il quintetto, che include il chitarrista Peter Hasslein e l'organista Peter Hecht, mostra grinta e coesione fin dall'attacco energico di "Ride The Sky", passando per "Keep Goin'" e la martellante "Everibody's Clown", fino a "Baby You're a Liar", con ribollenti fraseggi d'organo nel mezzo. La chitarra solista comanda quasi sempre le operazioni, ben supportata da una robusta sezione ritmica, con il bassista Dieter Horns in evidenza, anche in brani più articolati come "Toxic Shadows". La voce di Lawton è comunque il vero focus di un rock di grande impatto, che poco o niente concede alle formule del progressive, come dimostra il torrido finale di "Lucifer's Friend". Il secondo disco "Where the Groupies Killed the Blues" ( ) è pubblicato dalla celebre Vertigo nel 1972. Nonostante la vibrante apertura di "Hobo", in linea con l'esordio, l'album mostra un sapore prog più spiccato nell'articolazione dei sette pezzi. Ad esempio "Mother", con inserti di violino e mellotron nel variegato impasto strumentale, e soprattutto la minisuite in tre tempi "Summerdream", dove il corposo apporto di fiati e archi crea un'insolita atmosfera in chiaroscuro. Il lavoro del tastierista Hecth è più variegato, tra pianoforte, organo, mellotron e synth, e lo stesso cantante dimostra grande versatilità: entrambi danno il meglio nella bella title-track, che tiene insieme con disinvoltura sanguigno rock e complessità di scrittura. Se "Prince of Darkness" è un classico hard rock melodico ch'esalta ancora il vocalist insieme alla chitarra incisiva di Hesslein, la chiusura di "Burning Ships" è invece una morbida ballata sviluppata su chitarra acustica e percussioni, in un lento crescendo che testimonia la nuova dimensione della band tedesca. Questo magico equilibrio però non dura: il terzo album, "I'm Just a Rock'n'roll Singer" (1973) vira verso un pop-rock meno convincente, tra ballate melodiche ("Closed Curtains") e sussulti di rock classico ("Rock'n'roll Singer"), con strani intermezzi strumentali fuori contesto ("Blind Freedom"). Curiosamente, è il disco più fortunato del gruppo negli States, insieme al successivo "Banquet" (1974). Quest'ultimo cerca di combinare melodie pop, soul e rock-jazz in un insieme eclettico, ben suonato ("Spanish Galleon"), ma non sempre efficace. Adesso gli inserti di rock duro si legano a fatica con lo schema orchestrale, ad esempio in "Sorrow", mentre "High Flying Lady-Goodbye" è un altro rock'n'roll molto tirato. John Lawton se ne va nel 1976 per unirsi agli Uriah Heep, mentre la band inanella altri dischi di poca fortuna col nuovo cantante Mike Starrs, a cominciare da "Good Time Warrior" (1978). Ristampe Repertoire. ) è pubblicato dalla celebre Vertigo nel 1972. Nonostante la vibrante apertura di "Hobo", in linea con l'esordio, l'album mostra un sapore prog più spiccato nell'articolazione dei sette pezzi. Ad esempio "Mother", con inserti di violino e mellotron nel variegato impasto strumentale, e soprattutto la minisuite in tre tempi "Summerdream", dove il corposo apporto di fiati e archi crea un'insolita atmosfera in chiaroscuro. Il lavoro del tastierista Hecth è più variegato, tra pianoforte, organo, mellotron e synth, e lo stesso cantante dimostra grande versatilità: entrambi danno il meglio nella bella title-track, che tiene insieme con disinvoltura sanguigno rock e complessità di scrittura. Se "Prince of Darkness" è un classico hard rock melodico ch'esalta ancora il vocalist insieme alla chitarra incisiva di Hesslein, la chiusura di "Burning Ships" è invece una morbida ballata sviluppata su chitarra acustica e percussioni, in un lento crescendo che testimonia la nuova dimensione della band tedesca. Questo magico equilibrio però non dura: il terzo album, "I'm Just a Rock'n'roll Singer" (1973) vira verso un pop-rock meno convincente, tra ballate melodiche ("Closed Curtains") e sussulti di rock classico ("Rock'n'roll Singer"), con strani intermezzi strumentali fuori contesto ("Blind Freedom"). Curiosamente, è il disco più fortunato del gruppo negli States, insieme al successivo "Banquet" (1974). Quest'ultimo cerca di combinare melodie pop, soul e rock-jazz in un insieme eclettico, ben suonato ("Spanish Galleon"), ma non sempre efficace. Adesso gli inserti di rock duro si legano a fatica con lo schema orchestrale, ad esempio in "Sorrow", mentre "High Flying Lady-Goodbye" è un altro rock'n'roll molto tirato. John Lawton se ne va nel 1976 per unirsi agli Uriah Heep, mentre la band inanella altri dischi di poca fortuna col nuovo cantante Mike Starrs, a cominciare da "Good Time Warrior" (1978). Ristampe Repertoire.
|
"Where the Groupies Killed the Blues" |
||||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

 "Śniegowa panienka"
"Śniegowa panienka"














